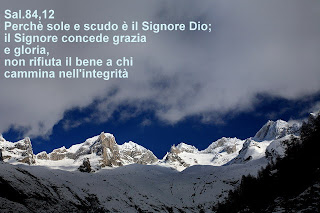 «La morte è il riposo, ma il pensiero della morte è il disturbatore di ogni riposo». La verità di questo assioma, annotato nel suo diario Il mestiere di vivere, Pavese l'ha dimostrata tragicamente col suo suicidio. Ai nostri giorni, però, si è adottato un altro sistema per neutralizzare questa inquietudine che è strutturale all'essere umano (chi non ricorda la differenza tra uomo e animale individuata da Pascal proprio in questa autocoscienza del "dover morire"?): o si narcotizza l'interrogazione bagnandola nel solvente della superficialità e dell'immediatezza gaudente (la "vita banale" kierkegaardiana), oppure ci si affida al vento illusorio del vivere senza mai invecchiare, tipico dell'immortalità" tecnologica, laddove però la parola "immortalità" è spogliata di ogni accezione metafisica platonica.
«La morte è il riposo, ma il pensiero della morte è il disturbatore di ogni riposo». La verità di questo assioma, annotato nel suo diario Il mestiere di vivere, Pavese l'ha dimostrata tragicamente col suo suicidio. Ai nostri giorni, però, si è adottato un altro sistema per neutralizzare questa inquietudine che è strutturale all'essere umano (chi non ricorda la differenza tra uomo e animale individuata da Pascal proprio in questa autocoscienza del "dover morire"?): o si narcotizza l'interrogazione bagnandola nel solvente della superficialità e dell'immediatezza gaudente (la "vita banale" kierkegaardiana), oppure ci si affida al vento illusorio del vivere senza mai invecchiare, tipico dell'immortalità" tecnologica, laddove però la parola "immortalità" è spogliata di ogni accezione metafisica platonica.Desimbolizzata e "decostruita", ridotta solo a questione biomedica, esorcizzata da nuovi "Eldorado biotech" alimentati dalla pur importante medicina rigenerativa, la morte si è, così, ritirata in un'oasi protetta, al massimo coltivata (e non molto appassionatamente) dalle grandi religioni. L'umanità più che "immortale" - concetto, come si diceva, mentalmente troppo hard - si considera "amortale", per usare una formula coniata da Ivan Illich e Edgar Morin. È nata, così, la "società postmortale", analizzata in modo esemplare dalla sociologa canadese Céline Lafontaine nel suo saggio Il sogno dell'eternità. La società postmortale (Medusa, Milano 2009). Il risultato di questa svolta non sembra concretamente molto esaltante, e non tanto per l'esito prospettato dal film giapponeseDepartures (2008) con la sua ironica agenzia di viaggi estremi "Necro Kosmetics", già anticipata dal celebre film di Tony Richardson, Il caro estinto (1965), quanto piuttosto per l'amara rilevazione di Norbert Elias nella sua La solitudine del morente (Mulino, Bologna 1985): «Mai come oggi gli uomini sono morti così silenziosamente e igienicamente e mai sono stati così soli». E anche qui l'anticipazione è già tutta in quel capolavoro che è La morte di Ivan Il'ič di Tolstoj.
Su questo orizzonte socio-culturale si affaccia in modo panoramico un monaco della comunità di Bose, Luciano Manicardi:
vorrei, però, che qualche lettore "laico" evitasse di alzare il sopracciglio del sospetto. Questo non è un libro né accanitamente apologetico né vagamente parenetico né tanto meno consolatorio o predicatorio. In una sequenza di tappe scarne, risalendo da "frammenti di attualità" (l'avvio è da un articolo di Aldo Schiavone su Repubblica), si ascende ai grandi canoni del passato per ripiombare in questo presente postmortale in cui si vive etsi mors non daretur e si scrivono senza imbarazzo frasi di questo genere: «Dobbiamo prepararci a gestire la morte, finché avremo, a che fare con essa».
Tutto l'immenso caleidoscopio di interrogazioni a cui si è costretti appena si penetra nell'orizzonte reale della morte, uscendo dalle illusioni di una vita pseudo-immortale che si attesta tra i non vivi e i non morti (Manicardi, ricorrendo a Dylan Dog -sì, il protagonista del famoso fumetto di Sclavi -, parla di "zona del crepuscolo"), continua a rutilare nelle poche pagine di questo studio prezioso e raffinato.
Si va dalla caduta del senso del limite creaturale, una categoria capitale anestetizzata da una (non dichiarata ma implicita) coscienza di onnipotenza, almeno futura, della tecnica, per giungere anche ad aspetti apparentemente minimali ma non certo minimi, come il ricorso all'eufemismo onde evitare l'osceno vocabolo "morte", che diventa invece una semplice "scomparsa o dipartita o perdita". Si giunge anche a quella frontiera estrema che si vuole, prima, rimuovere cronologicamente, allungando la vita e, poi, rimuovere ideologicamente cancellandola dal programma esistenziale. Come scrive Lafontaine, «la postmortalità comincia proprio dove le frontiere tra la vita e la morte s'ingarbugliano a un punto tale che alcuni prendono in considerazione la possibilità di un loro superamento». Manicardi s'inoltra anche nella nuova concezione del corpo che ha nel cyborg, ossia un corpo umano integrato sempre più da organi meccanici e artificiali, il suo simbolo, ponendosi la domanda-corollario: questo corpo "protesizzato", senza tempo, storia ealterità, è ancora un corpo umano, tenendo conto della complessa interattività psiche-soma?
Ma l'autore non si accontenta di registrare le coordinate della mappa postmortale. In essa semina il dubbio (che in realtà per lui e per molti è una verità) di una concezione umanistica alternativa.
Bellissimo è il capitolo "Tra l'oggi e il domani" ove si rimettono sul tappeto - vanamente disinfettati dai laboratori biomedici postmortali contemporanei - tutti i germi benefici delle domande radicali, grandi e minori: paura, corporeità e spiritualità, iniziazione del morire e al morire, la morte come dubbio dell'esistenza su di sé, la temporalità, la libertà e la responsabilità, il lutto e i riti funebri, l'anzianità, il declino della natalità legata al declino della mortalità e, alla fine, la domanda ultima su "quale vita" la postmortalità propone (una questione che aveva affrontato anche Turoldo in uno dei suoi rari romanzi ... e poi la morte dell'ultimo teologo del 1969). In questo aggrovigliarsi di quesiti e di risposte non poteva mancare la voce della Bibbia.
E anche in questo caso non perché è un monaco che scrive, ma perché per secoli sul morire e sulla "postmortalità" (ma in tutt'altro senso rispetto a quello odierno...) le Scritture Sacre ebraico-cristiane sono state il "grande codice" ermeneutico. Qui entra in scena il paradosso cristiano, anzi, l'ossimoro della morte-vita, della fine-inizio, del tempo-eternità, dell'«amore forte come la morte», della «morte come l'altra faccia della vita rispetto a quella rivolta ora a noi», per usare le parole di Rilke.
Un discorso che Manicardi solo evoca, lasciandolo sospeso perché ci si inoltri in un ulteriore cammino su un sentiero ancor più arduo. Fermo restando che, a valle, permane il monito del grande teologo, filosofo e beato John Henry Newman: «Non aver paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non cominciare mai davvero».

Nessun commento:
Posta un commento