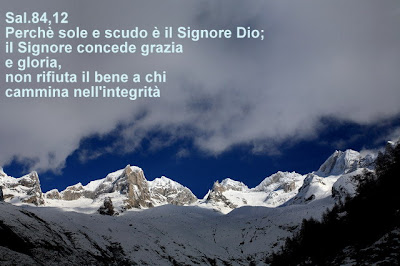 L'esperienza del dolore
L'esperienza del doloreIn questo testo uso dolore e sofferenza come termini equivalenti. Ma c'è una differenza da non sottovalutare: “sofferenza” esprime «... la durata e la profondità di un dolore ed inoltre la pluridimensionalità come radicamento della sofferenza nel corpo fisico e sociale dell'uomo» (Sölle D., Sofferenza, Queriniana, Brescia 1976, p. 29).
1. L'esperienza del dolore e il suo linguaggio
Il dolore si conosce solo per esperienza. Ogni esperienza produce conoscenza. Il tipo d'esperienza prodotto dal dolore ha caratteristiche sue proprie, irriducibili alle altre modalità di esperire la realtà. La sua radicalità fa irrompere una diversa visione e, quindi, un modo nuovo di comprendere l'accadere del mondo (per queste riflessioni si veda: Natoli S., L'esperienza del dolore, Feltrinelli, Milano 1986).
Sotto il segno del dolore il mondo appare trasformato nella sua interezza: in questo senso il dolore appartiene al genere delle esperienze cruciali, poiché esso sottopone gli uomini ad una tensione che, quando non produce distruzione, accresce certamente la percezione. Il dolore, qualunque sia la sua origine ed in qualunque modo sia vissuto, rompe il ritmo abituale dell'esistenza, produce quella discontinuità sufficiente per gettare nuova luce sulle cose ed essere insieme patimento e rivelazione. Il mondo si vede in un modo in cui mai prima s'era visto (ivi, p.8).
Il dolore è un fatto personale, tocca l'uomo nella sua profondità; ma insieme è anche un fatto universale, cosmico. In ogni soffrire c'è un riverbero del dolore universale, in tutti i suoi aspetti: fisico, psichico, sociale. Un intreccio di singolare e universale, mai del tutto districabile, che tuttavia permette all'esperienza del dolore di farsi «comunicabile». Da una parte il dolore separa, crea confini fra chi soffre e chi non soffre, riduce la stessa vita. Il pericolo, in questo caso, è che la sofferenza sia tale da rendere l'uomo muto, perché viene distrutta tutta la sua capacità di comunicare. Dall'altra, del dolore si parla perché in esso c'è un riverbero del dolore universale e della stessa possibilità del soffrire che coinvolge tutti. Il linguaggio può essere in una prima fase urlo, lamento, preghiera, per diventare in una seconda fase sempre più articolato, riflessione, espressione di un senso che coinvolge. In queste due fasi il linguaggio tende già a una trasformazione: ristabilisce una comunicazione, tende a rendere solidali, a organizzare un aiuto e una liberazione (Sölle, o.c., p. 107). Nascono così
le grandi immagini del dolore entro cui quell'esperienza è stata vissuta: gli scenari della sofferenza sono dunque i luoghi in cui l'esperienza individuale del dolore si salda col senso universale del soffrire. Queste scene, allora, non sono astrazioni, non sono una filosofia del dolore nel senso in cui comunemente si parla di filosofia, ma fanno tutt'uno con il vissuto della sofferenza, poiché costituiscono le forme proprie attraverso cui gli individui patiscono e nel contempo si rendono interpreti della loro sofferenza (Natoli, o.c., pp. 10 e 11).
2. I due grandi scenari del dolore in Occidente
Questi scenari, che esprimono il senso della sofferenza e permettono di viverla, sono diversi, coerenti con le diverse visioni del mondo. Si vive il dolore con modalità storiche e concrete, inseparabili dall'orizzonte interpretativo in cui l'esperienza è posta ed entro cui si svolge. È per questo che le grandi visioni della sofferenza non sono astratta interpretazione o conoscenza separata, ma «modalità storica e concreta di vivere il proprio dolore, di sopportarlo e di morirne» (Ivi, p.34).
In Occidente ci troviamo di fronte a due grandi scenari: quello greco e quello ebraico-cristiano. Si può dire che la storia dell'Occidente risulta dalla fusione di questi due orizzonti: uno tragico e uno redentivo; uno rinchiuso nell'orizzonte terreno, l'altro aperto a una speranza. I greci ci insegnano la “fedeltà alla terra”, gli ebrei-cristiani la “seduzione del Regno”. «Fedeltà alla terra significa amare questa terra per se stessa con tutto il suo dolore, nella convinzione che vita e morte sono inscindibili, che nulla può essere veramente vissuto al di fuori delle possibilità che il presente offre ad ogni uomo. Per questo, mantenersi fedeli alla terra significa aderire al qui e ora del mondo cercando di attingere, nella situazione in cui si è, il fondo delle proprie possibilità». Parlare di “seduzione del Regno” significa parlare non di qualcosa dì diverso della “terra”, ma di questa terra liberata.«Una terra liberata dal dolore, dalla morte, dal male. Il Regno non è l'al di là del mondo, non è l'altro mondo, ma è il mondo a venire, è questo mondo al futuro» (Ivi, pp. 251-252)
Se per i greci il dolore è esperienza della tragicità dell'esistenza, segno di un insanabile dissidio a cui non c'è risposta, per il giudeo questa insanabilità non è possibile, perché YHWH è il Dio della speranza. Non si tratta di quella speranza che è patrimonio comune a ogni uomo, ma di quella speranza che fa sperare nonostante tutto, che è senza limiti: in una parola, è assoluta.
3. Lo scenario biblico
Nella Bibbia all'interno del grande scenario dato dalla fede nel Dio della speranza, troviamo diversi sistemi, a volte assai diversi fra loro, che indicano non solo l'evolversi nel tempo della concezione del dolore, ma anche il modo diverso di porsi dell'uomo di fronte a Dio.
Con Ravasi (Giobbe, Borla, Roma 1984, pp. 81-96) possiamo brevemente presentare questi diversi sotto-scenari:
• La proposta storiografica, fondata sulla contrapposizione fra Dio che crea una realtà “molto buona” e l'uomo che provoca liberamente il male, che diventa fonte di ingiustizie e dolore.
• La proposta sapienziale: è la proposta che Giobbe respinge. Il male dipende dalla colpa (e dalla limitatezza).
• La proposta profetica: la sofferenza è vista nella linea storiografica. Qui tuttavia c'è qualcosa di più: il dolore è da una parte appello concreto lanciato all'uomo perché si converta, dall'altra ha una fecondità sua propria nascosta nel dolore innocente. Il carme del servo sofferente, su cui torneremo, è in questa ultima linea. Non è chi soffre che confessa il suo peccato - e siamo di fronte anche a una risposta agli amici di Giobbe - ma sono gli spettatori che confessano il loro peccato caduto su di lui. «Il binomio finora inscindibile dolore-castigo è spezzato, il castigo è solo nostro, il dolore è diventato suo. E il suo dolore diviene salutare per noi, ci dà pace, genera in noi pentimento e perdono, le sue cicatrici sanguinanti ci curano. Ma la sofferenza e la morte non sono la foce definitiva verso cui corre la vita del Servo. Anzi, la morte fa fiorire il mistero di fecondità che quel dolore conteneva» (Ivi, p.86).
• La proposta deuteronomica: la sofferenza è l'espressione della pedagogia di Dio. Il dolore educa, purifica, fa maturare. Frutto di questa paideia divina è una nuova conoscenza: l'uomo esperimenta la sua dipendenza da Dio.
• La proposta apocalittica: essa è fondata su un dualismo fra il presente e il futuro, fra bene e male, che viene superato appellandosi a un mondo futuro, nuova e definitiva edizione in positivo del mondo presente.
• La proposta salmica: la preghiera è posta sotto il segno del dolore e della supplica. Il male è presentato quasi come una potenza demoniaca, contro la quale il fedele non può che invocare Dio.
Come si può constatare, il Dio della speranza, seppur in modi diversi, sovrasta sempre qualsiasi proposta. Lo scenario è, come detto, unico, anche se declinato in maniere diverse. Un insieme di temi e riflessioni che ritorneranno anche nel Nuovo Testamento, pur nella luce del crocifisso a cui Dio dona vita eterna.
Nello schema soteriologico che, con Paolo, diventerà decisivo, confluiranno le diverse interpretazioni della morte di Gesù: dalla sofferenza del profeta martire escatologico a quello storico salvifico che accentua l'aspetto di espiazione del peccato. In questo schema (sviluppato sullo sfondo del Salmo 22 e di Isaia 53) il giusto sofferente e il martire escatologico confluiranno fino a quello esplicitamente soteriologico, forse già presente nel significato che Gesù ha dato alla sua morte.
Il Servo sofferente
1. L'Antico Testamento
a. L'«abbandonato da Dio»
Prima di affrontare direttamente il tema del Servo sofferente del Deutero-Isaia, è opportuno fermarsi, seguendo le pagine che Von Balthasar dedica al Mysterium paschale (Von Balthasar H. U. Mysterium paschale, in Mysterium salutis, vol.VI, Queriniana, Brescia 1971, pp.171-412) sulla «connessione esistente tra la passione e i motivi veterotestamentari del “giusto consegnato”, della “sofferenza dell'innocente”, del martirio per la fede» (Ivi, p.225). Temi che ritorneranno nei canti del Servo di YHWH, che tuttavia hanno un loro svolgimento autonomo in tutto l'Antico Testamento. Come non ricordare «le pitture di terrore» in Lv.26,14-39 e Dt.28,15-68: consegnato ai nemici, tremante d'angoscia, con un «cielo di bronzo sopra di sé» il popolo precipita lontano da Dio, ludibrio di tutti, «distrutto da Dio con piacere», ricacciato in Egitto, paese della desolazione e della maledizione - e bisogna qui richiamare anche il tardo quadro simbolico della tenebra egiziana nel libro della Sapienza, consistente essenzialmente in un'angoscia interiore (davanti al nulla! davanti agli spettri!: Sap.17,3; cf. Lv.26,36) dove si è «chiusi in una prigione senza chiavistelli», «incatenati nelle tenebre», in mezzo ad una «angoscia salita dalle profondità dell'Ade impotente». Si aggiunga a questa tematica
l'autentico abbandono da parte di Dio del singolo che sprofonda solitario (Giobbe) o in rappresentanza del popolo (Geremia). L'abbandono del popolo da parte di Dio è autentico e unico perché Israele ha conosciuto una presenza unica e autentica di Dio. Nell'esilio, lontano dalla terra di Dio e tra le rovine del tempio, (il popolo) comprende cosa significa che Dio lo ha abbandonato e gli è diventato “nemico” (Lam.2,5), che a Lui ci si può rivolgere ormai come un assente (Ibidem, pp. 225-226).
Non è qui possibile dilungarci in particolare sulla figura di Giobbe che di fronte alla sofferenza del giusto chiama direttamente in causa Dio. Vi torneremo brevemente più avanti, perché il Servo di YHWH è una risposta a Giobbe.
b. Il Servo di YHWH
Ho già accennato brevemente, parlando della proposta profetica, al significato della sofferenza del Servo di YHWH su cui si dilunga il Deutero-Isaia. L'importanza di questi testi per l'elaborazione della cristologia primitiva è a tutti nota. Non solo il titolo di “servo” dà senso all'aspetto umiliato dell'umanità di Gesù, ma precisa anche il modo con cui si deve vedere la sua morte. Come è noto in Paolo l'annuncio del Vangelo e della croce di Cristo coincidono: nella croce Dio riconcilia il mondo con sé (2Cor5,18): «È scomparso il vecchio, ecco è sorto il nuovo».
I testi fondamentali sono i canti del Servo del Signore di Isaia42,1-4;52,13-53,12 che non sono da separarsi da 49,1-7 e 50,4-11. Ma non sono gli unici. In particolare non devono essere separati dal Salmo 22 (lamento e preghiera dell'innocente perseguitato) e da altre numerose figure bibliche (salmi 69,31,34,118,41,42 e 43: un insieme di testi caratterizzati da un unico intreccio: il tormento e l'ignominia del giusto che è sempre liberato e glorificato per pura grazia da Dio). Queste figure, se in alcuni dei testi citati soffrono per il giudizio di Dio sul popolo peccatore, in altri testi sono vittime innocenti perseguitate dai nemici di Dio. Isaia 52ss. armonizza queste due tradizioni: le sofferenze del Servo sono un giudizio sul peccato, ma un peccato che il Servo porta al posto degli altri (cfr., Dodd CH. H., Secondo le scritture, Paideia, Brescia 1972; in particolare pp. 102-107).
Come è noto, il dibattito esegetico sui canti del Deutero-Isaia è assai vivo ancor oggi; in particolare si discute sul carattere di questa figura (individuale o collettiva) e sui suoi riferimenti storici (si veda Grelot P., I canti del Servo del Signore, Dehoniana, Bologna 1983). Al di là di questi punti controversi, che non ci interessano direttamente, ciò che deve essere sottolineato è, con Grelot, il fatto che
questi oracoli hanno sempre per orizzonte la realizzazione piena del disegno di Dio, di cui Israele è il beneficiario [...]. Fin dalla composizione questi testi sono
- stati legati alla fede e alla speranza di Israele, in un momento critico della sua storia. Nelle loro funzioni diversificate, relative ad avvenimenti precisi e manifestati dalle forme letterarie, i canti si proponevano come obbiettivo principale di custodire questa fede e questa speranza, di schiudere al popolo l'«Avvenire di Dio» arricchendo in alcuni punti il modo con cui esso, fino a quel momento, aveva compreso i suoi disegni, di fronteggiare eventualmente le crisi che potevano passare la fede e la speranza, se talvolta gli avvenimenti sembravano contrastarle perché la sofferenza e la morte del Servo effettivamente erano in contrasto con le prospettive aperte dagli oracoli di Is. 42 e 49. E in questa forma che i canti sono stati introdotti nella raccolta del Deutero-Isaia, esattamente come gli inni, gli oracoli e i discorsi che celebravano in modo lirico la venuta della salvezza di Dio (Ivi, p.69).
Siamo di fronte, se ben riflettiamo, al superamento della concezione del principio di retribuzione in favore di una concezione in cui la gratuità di Dio, la sovrabbondanza del suo dono passano in primo piano. È il giusto che, proprio perché vittima innocente, restituisce al mondo la giustizia.
Il Servo sofferente di YHWH è la risposta a Giobbe. Se mai per Giobbe può esserci una risposta. Ma ammesso che quella risposta esista, non può essere diversa da quella del Servo di YHWH. (...) Il “Servo” risponde con la sua stessa vita a quel dramma che in Giobbe viene figurato. Egli soffre senza capire neppure il perché, ma così facendo mostra che l'unico modo per dare soluzione al dolore è attraversarlo. Il soffrire silenzioso del Servo non equivale al rinchiudersi in un dolore muto, non è un pietrificarsi entro la propria pena, ma è proprio quel consegnarsi ad altre mani che il finale di Giobbe suggeriva. Si ha a che fare con un silenzio che non isola, ma mette in contatto, con un tacere che attende il rinvenire della parola di Dio, il soffio del suo spirito che vivifica chi ha raggiunto le porte della morte. Infatti, il Servo viene glorificato per la sua stessa sofferenza (...) La sofferenza, considerata alla luce del suo esito, prende dunque senso: c'è un soffrire che realizza, un dolore efficace che toglie quella medesima colpa che lo origina e abolendo quella si autoestingue definitivamente (Natoli, o.c., pp. 230-231).
Ma con queste ultime osservazioni, siamo già passati al Nuovo Testamento.
2. Il Nuovo Testamento
a. Gesù di Nazareth, servo sofferente
È a tutti noto che la narrazione della passione e morte di Gesù è, forse, il testo più antico del Nuovo Testamento. I vangeli, come scrive M. Kähler, sono «racconti della passione preceduti da un'ampia introduzione». La croce non è un evento isolato, «ma l'evento al quale è orientata la storia della sua vita e dal quale ricevono il loro significato tutti gli altri eventi» (Von Balthasar, o.c., p. 177). Non è qui il posto per ricostruire le varie redazioni di questi racconti (si veda, per un primo approccio, Cousin H., Il profeta assassinato, Borla, Roma 1977). È tuttavia fuori dubbio che anche nelle più antiche il tema del giusto sofferente (Sal.22) e del Servo di YHWH (Is.53) sono già presenti in filigrana. Con Grelot possiamo dire che
il racconto più arcaico della passione di Gesù e la prima interpretazione della sua morte, in un primo momento incomprensibilmente scandalosa, hanno trovato nel testo di Isaia52,13-53,12 un chiarimento inatteso [...]. Inoltre il racconto dell'Ultima Cena conservato da Paolo invita a domandarsi se questa lettura del testo non sia stata inaugurata da Gesù stesso, che ha potuto vedervi l'indicazione della volontà di Dio su di lui nel momento in cui andava compiendosi il suo destino umano (Grelot, o.c., p.142).
L'Alleanza si realizza in e per la morte del giusto sofferente che, ormai, per i cristiani non è che il Messia sofferente. È importante sottolineare questo passaggio. La lettura della Scrittura è sempre aperta; essa cresce nel tempo. Solo a partire dalla fede in Cristo si è potuto parlare del Messia sofferente a proposito del Deutero-Isaia. Il Servo non è contrassegnato da nessun tratto regale, né dall'unzione propria di questi personaggi. Il passaggio dall'ermeneutica ebraica a quella cristiana avviene per il riconoscimento, da parte dei cristiani, di Gesù come l'unico giusto che ha esperimentato nella sua vita e morte il destino riservato al Servo del Deutero-Isaia. Come osserva Von Balthasar, «è necessaria la prospettiva del compimento per scorgere la convergenza di tutta l'esistenza “tipologica” di Israele verso il Triduum mortis; questa convergenza non è certo deducibile da testi singoli» (Von Balthasar, o.c., p. 176). È alla luce della resurrezione che si rilegge il passato e si comprende la croce. «La resurrezione per i discepoli è un evento del tutto imprevisto. I vangeli fanno capire che la resurrezione di Gesù giaceva completamente al di fuori di ciò che i discepoli, a buon diritto, avrebbero potuto attendersi. Per una resurrezione di Gesù non c'era spazio alcuno all'interno delle rappresentazioni che essi avevano a disposizione» (si tratta di una affermazione di K. H. Rengsdorf, citato da Von Balthasar, o.c., p. 339).
Più chiaramente: il significato salvifico del «per noi» della morte di croce (già in Is.53), fu dedotto dalla resurrezione, tanto che croce e resurrezione rimangono inseparabili, così che non è possibile parlare del Messia sofferente se non alla luce della resurrezione. Del resto per Giovanni “esaltazione” e “glorificazione” non sono che i momenti di un unico evento. Tutto ciò non deve proibirci una considerazione particolare sul senso della sofferenza del Venerdì santo. C'è una considerazione della Passione che deve essere colta in tutta la sua profondità, per non lasciar spazio ad una sofferenza dimidiata. Comprendere la Passione - il Messia sofferente - significa comprendere non solo la storia della Passione come storia della colpa, ma anche come destino di finitudine e morte (si veda Metz J. B., Redenzione ed emancipazione, nell'opera di AA.VV, Redenzione ed emancipazione, pp. 152-177.
b. Alle radici della sofferenza: l'assenza di Dio
Se si vuoi parlare della sofferenza del Messia, non si può non sottolineare la pesantezza sotto cui la croce appare a Gesù già nel suo preannunciarsi: piange ed è sconvolto; vorrebbe sfuggire dall'Ora che sta per venire (Gv.11,33ss.;12,27-28). Ma «incarnarsi, come non essere ricevuto (Gv.1,14.11.), è già essere triturati in anticipo (6,54-56), scomparire agonizzando sotto la terra (12,24)» (Von Balthasar, o.c., p. 179). E se Dio si è fatto uomo per morire sulla croce, è arrivato il giorno in cui la sofferenza ha reso Dio inaccessibile. È qui il punto più profondo del soffrire. Non c'è più grido, ma solo il vuoto, il nulla, il non senso. Scrive ancora Von Balthasar:
Se senza il Figlio nessuno può vedere il Padre (Gv.11,18), nessuno può venire al Padre (Gv.14,6), a nessuno il Padre può essere rivelato (Mt.11,27), allora se il Figlio, Parola del Padre, è morto, nessuno può vedere, ascoltare Dio, arrivare a lui. E di fatto si dà questo giorno in cui il Figlio muore e Dio è inaccessibile. Anzi Dio si è fatto uomo - come la tradizione ci ha mostrato - proprio per questo giorno. Si può dire senz'altro: egli è venuto per portare sulla croce i nostri peccati, per lacerare il documento del nostro debito trionfando sulle potenze e sulle potestà (Col.2,14s.). Questo “trionfo” però si compie nel grido dell'abbandono di Dio nelle tenebre (Mc.15,33-37), nel «bere il calice», nel «reggere al battesimo» (Mc. 10,38), nella morte e nell'inferno. Dopo cala il silenzio, racchiuso nel sepolcro a cui viene apposto il sigillo. Alla fine della passione con la morte della Parola di Dio, anche la Chiesa non ha più parole. Mentre il seme di frumento muore, non c'è nulla da raccogliere.
(...) È necessario prendere con tutta serietà il fatto che quest'uomo Gesù che era la parola, la manifestazione e la mediazione di Dio, muore e che viene a cessare quindi la rivelazione che era nella sua vita, così come viene sepolto, perde la parola e non manifesta e comunica più. (...) Quanto vi è di proprio nella teologia del Venerdì santo non consiste nel compimento di un atto filiale di autodonazione del Figlio incarnato al Padre, così come è strutturalmente presente nella morte di qualsiasi uomo. Piuttosto questo proprium consiste in qualcosa di assolutamente unico che si esprime nel realizzarsi di una completa assenza di Dio, cioè di tutto il peccato del mondo come dolore e sprofondamento nella «seconda morte» e nel «secondo caos», al di fuori del mondo ordinato all'inizio da Dio (Ivi, p. 204-206. Ivi, pp. 248-250).
Siamo di fronte alle tenebre più totali, a qualcosa che sommerge tutta l'anima. «Dio mio, perché mi hai abbandonato»; e se per gli antichi, come continua il salmo, ci fu risposta, in quel momento non appare alcuna risposta. Nasce anzi la consapevolezza che l'invocazione di essere risparmiato, non avrà risposta. «Ogni sofferenza estrema esperimenta l'abbandono da parte di Dio. Nell'abisso della sofferenza gli uomini si sentono rinnegati e abbandonati da tutto. Ciò che dava senso alla vita è diventato vuoto e ha perso valore. (...) Ogni sofferenza che viene sentita come minaccia alla propria vita tocca il rapporto con Dio, se prendiamo questa espressione nel senso strettamente teologico (...), come ciò “in cui si confida”» (Lutero - Solle, o.c., p. 123)
Ripeto: morte e resurrezione sono inscindibili. L'annuncio cristiano riguarda il crocifisso risorto. Ma se dal fondo dell'abisso nasce una luce, essa nasce solo perché si è vissuto fino all'estremo l'abbandono. Simone Weil, che ha scritto pagine grandissime sulla sofferenza, osserva: «E se in queste tenebre, in cui non vi è nulla da amare, l'anima smette di amare, l'assenza di Dio diviene definitiva (...). È necessario che l'anima continui ad amare a vuoto o per lo meno a voler amare, anche se soltanto con una parte infinitamente piccola di se stessa. Allora un giorno Dio stesso viene a rivelarsi a lei e a mostrarle la bellezza del mondo» (Queste affermazioni sono contenute in una lettera che si può trovare in traduzione italiana in Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972, pp. 23-46).
La continuità, il ponte sullo iato rappresentato dalla morte, viene gettato dall'amore assoluto di Dio per l'uomo, che fonda pure la possibilità di non spegnere del tutto la capacità di amare. Rottura e continuità, ben rappresentate dalle piaghe che il risorto porta con sè. Beati coloro che soffrono: l'amore attivo non può che portare alla sofferenza, anche se essa non è voluta, anche se l'amore non crea la sofferenza.
Il Messia sofferente datore di vita
1. Il linguaggio del crocifisso
Nel volto sofferente di Gesù di Nazareth - di colui che noi confessiamo, per la sua morte e resurrezione, il Messia - la fede cristiana da sempre ha letto non solo un'esperienza individuale, ma la rivelazione del modo con cui Dio sta accanto agli uomini. Nelle tesi 19 e 20 della Disputa di Heidelberg del 1518, Lutero scriveva: «Non ille digne Theologus dicitur, qui invisibilia Dei “per ea, quae facta sunt, intellecta conspicit” sed qui visibilia et posteriora per passionem et crucem intelligit». Per Lutero la vera conoscenza di Dio è nel Cristo crocifisso. «È la vita, la morte e la sofferenza - scriverà nel commento alla lettera ai Galati - che fanno il teologo, e non la conoscenza, la lettura e la speculazione».
Al di là della polemica con la teologia scolastica, Lutero ci richiama con forza alla centralità della Croce nella conoscenza di Dio. Una conoscenza che rivela e nasconde; ciò che vediamo non è infatti il volto di Dio - «tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo» (Es.33,23) - ma soltanto le sue “spalle” (posteriora Dei), qualcosa che contraddice le nostre attese. Dio è cioè visibile nella debolezza e nella sofferenza; una visibilità sub contraria specie. Ed è questa anche la direzione della ricerca teologica contemporanea, sempre più concentrata sul discorso di Dio alla luce della passione e morte di Gesù. Concentrata, cioè, su quello che è il tema suo proprio.
L'interpretazione cristologica di Dio porta all'approfondimento della sua passione e morte non tanto per coglierne l'aspetto soteriologico, quanto per approfondire la conoscenza di Dio e del mondo. «È sulla croce che l'amore di Dio che si aliena conosce la radicalità suprema. La croce rappresenta la massima esteriorizzazione possibile ad un Dio che si dona nel suo amore; essa è l'id quod maius cogitari nequit, l'autodefinizione insuperabile di Dio stesso» (Kasper, W., Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1984, p. 264). «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv.12,32): nel massimo della sua abiezione, egli si rivela in tutta la sua potenza. Una potenza a cui non attenta la sua kenosi, perché questa potenza è diversa da quella del mondo. Anzi il fatto che la sua gloria possa apparire nella sofferenza e nell'abbandono, indica già il modo con cui possiamo intendere questa kenosi.
Come è noto, il termine kenosi deriva dall'inno di Fil.2,6-11. Liberamente Gesù Cristo ha rinunciato alla sua condizione divina per assumere quella dello schiavo. La sua rinuncia è espressione della sua libertà. L'amore autentico è accettazione dell'altro e coinvolgimento, che significano autolimitazione e volontà di rendersi vulnerabili:
E così amore e sofferenza risultano strettamente legati. Ma la sofferenza dell'amore non è soltanto un coinvolgimento passivo, bensì anche un attivo lasciarsi coinvolgere. Appunto perché è amore, Dio può anche soffrire e così rivelare la propria divinità. L'alienazione della croce non sarà allora una sdivinizzazione di Dio, bensì la sua glorificazione escatologica. La distinzione intradivina eterna di Padre e Figlio è la condizione teologico-trascendentale di possibilità dell'autoalienazione di Dio nell'incarnazione e sulla croce. E questa non è speculazione, per quanto interessante, ma sta ad attestarci che fin dall'eternità in Dio c'è spazio per l'uomo, uno spazio per un reale sympathein con la sofferenza degli uomini. Il Dio cristiano, quello compreso alla luce di Gesù Cristo, non è un Dio a-patico, ma un Dio sim-patico nel senso vero e proprio del termine, un Dio cioè che soffre con l'uomo. (...) Ma il fatto che Dio soffre non significa che egli divinizzi la sofferenza. Dio non divinizza la sofferenza, ma la redime, poiché la sofferenza di Dio, la .quale scaturisce dalla libertà del suo amore, vince l'ineluttabilità del soffrire e con essa ogni dolore estraneo e incomprensibile. In tal modo l'onnipotenza dell'amore divino supera l'impotenza del soffrire. Pur non essendo eliminata, la sofferenza viene tramutata dall'interno, trasformata in speranza. Ora l'ultima parola non spetta più alla kenosis ed alla passione, bensì all'elevazione e trasfigurazione [...] La cristologia della kenosis si apre ad una cristologia pasquale dell'elevazione e trasfigurazione (Ivi, pp. 265-267).
2. Dalla lettura storica alla lettura esistenziale
È importante tener presente come la lettura della Bibbia - vale per gli Ebrei come per i cristiani - è sempre in rapporto ai problemi vitali dei credenti. La Parola deve sempre risuonare nell'oggi. Ciò evidentemente non deve farci trascurare il lavoro per porre il testo nell'oggi dell'autore e della comunità per la quale scriveva. Se si vuole, si tratta sempre, sia per il passato che per il presente, dell'oggi di Dio. Riflettere come qui abbiamo fatto sui testi del Messia sofferente, significa entrare non solo in
un'esperienza storica mai finita e difficile da ricostruire sotto i suoi aspetti empirici, ma sul limitare di una esperienza spirituale che continua attualmente nella vita di fede tanto dei giudei quanto dei cristiani. Si ritrova così il legame tra fede e storia nel mondo della Bibbia [...] e la lettura critica è obbligata a prendere in considerazione l'aspetto esistentivo dei testi in modo ancora maggiore. (...) Confrontando la nostra esistenza con l'esperienza interiore che tali testi lasciano scorgere, noi scopriremmo il mezzo per decifrare il senso delle nostre prove e speranze, della nostra morte e delle nostre relazioni con Dio, nonostante le differenze notevoli tra la situazione storica (Grelot, o.c., pp. 248-249).
La risposta non può che essere positiva. Come gli Ebrei leggevano i Canti del Servo orientati sempre al loro oggi, con una interpretazione che oggi chiameremmo esistenziale, così per i cristiani possiamo parlare della stessa interpretazione
a condizione di rendersi conto che la mediazione di Gesù, Servo di Dio sofferente e glorificato, interviene sempre perché il cristiano comprenda la propria esistenza. [La teologia del Nuovo Testamento] più che una speculazione sull'essere di Gesù si presenta come una riflessione concreta sulla sua esistenza, dal momento della vocazione nel seno della madre fino alla morte e oltre, sulla relazione con Dio e con gli uomini peccatori, sul suo ruolo di «alleanza del popolo e luce delle nazioni»: tutti temi essenziali nella cristologia neotestamentaria sui quali si basa la comprensione dell'esistenza cristiana (Ivi, pp. 248-250).
Ogni conoscenza autentica di Dio non può che partire dal fatto che egli è nascosto a noi. Già Israele ha sofferto questa esperienza: «Sì, tu sei un Dio che si nasconde, o Dio d'Israele, Salvatore» (Is.45,15). La sofferenza del Messia e la sua croce sono in questa linea, con una radicalizzazione, se si vuole, data dal fatto che i cristiani credono che il Messia sia venuto. Ma come aver fede - nel significato più genuino: abbandonarsi, affidarsi - in Colui che appare sconfitto? È per questo che, se è vero che l'Antico Testamento va interpretato alla luce di Cristo, resta altrettanto vero che abbiamo bisogno dell'Antico Testamento per interpretare Cristo. Solo alla luce di tutta la lunga storia della salvezza noi possiamo, per quanto è possibile, interpretare la presenza di Dio in mezzo a noi. Ciò è necessario per non cadere in una storia astratta della vicenda di Cristo, una storia che non sa assumere la sorte dei vinti, che vede la responsabilità delle colpe e dei tradimenti solo degli altri, e che canta troppo frequentemente vittoria. Solo quando ci si sa confrontare - anzi, assumere - con il dolore, con la finitudine, con la mortalità, con il nichilismo che divora le creature, solo allora diventa possibile cogliere in fondo all'abisso quella luce che segnala una Presenza che non ci abbandona, che è anzi liberante, ma non a buon prezzo. La storia della libertà, per toccare anche l'aspetto sociale e politico della redenzione, rimane sempre anche una storia della passione. Solo gli storicisti possono interpretare la storia come un susseguirsi di vittorie, cancellando da essa i vinti.
È importante a questo punto determinare correttamente il vero fine della redenzione. Contrariamente a quello che normalmente si pensa, redenzione e libertà, e non redenzione e salvezza, sono i due concetti reciprocamente ordinati. Il termine salvezza non è sufficientemente profondo per potersi adeguare alla pienezza di ciò che si vuol esprimere. La liberazione è ciò che il credente si aspetta dal futuro di Dio: libero per Dio e per la realtà. La terminologia paolina è esplicita; la libertà può essere considerata il concetto chiave della sua antropologia. Un concetto che tocca direttamente la morte, il peccato, la sofferenza (liberi da) e che fonda un nuovo rapporto con Dio: la figliolanza e l'eredità definitiva. La realizzazione di questa libertà non sarà che la realizzazione di ciò a cui aspira tutto il creato: la creazione intera, che oggi geme e soffre, sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, in vista della splendida libertà dei figli di Dio (Rm.8,21 - Cfr. Grillmeier, A. in Mysterium salutis, vol. VI, cit., pp. 417 e 443ss).
A questo proposito non sarà inutile ricordare, nonostante le difficoltà dell'interpretazione, il descensus ad inferos, troppo velocemente eliminato come topos mitologico. Questo descensus, come osserva Metz, «questo essere-coi-morti (del crocifisso), dimostra il movimento liberatore originario della storia della redenzione, senza il quale ogni storia della libertà si riduce a storia della natura e si placa tendenzialmente in essa. [...] Nella luce di questa storia della redenzione non c'è soltanto una “solidarietà in avanti”, con le generazioni future, ma anche una “solidarietà rivolta all'indietro”, con gli ammutoliti dalla morte e i dimenticati; per essa non c'è soltanto una”rivoluzione in avanti”, ma in certa misura anche una rivoluzione all'indietro, in favore dei morti e delle loro sofferenze. Essa non contempla dal punto di vista dei vincitori, dei riusciti e degli arrivati, ma da quello dei vinti e delle vittime del teatro mondiale aperto della nostra storia» (Metz, o.c., pp. 168-169).
3. Soffrire con, vivere con
La fede cresce e si invigorisce non malgrado, ma grazie alle contraddizioni che scatena. Come è stato detto, ridurre l'uomo a «animale razionale» significa mutilarlo. L'amore che muove il desiderio, che crea conoscenza non può essere chiuso entro i limiti della pura ragione, anche se essa deve sempre vigilare. «Nell'insituabilità di ogni attimo che trascorre, nella tensione convergente e divergente insieme tra il mai più, l' ora , e il sempre , l'amore ricompone il significato e ritesse gli strappi, che incessantemente si riproducono, dell'esistenza del singolo. Il presente - trapassato o trafitto dalla dissipazione degli eventi - si tiene insieme lottando contro le trafitture reali e virtuali, le ricadute negli errori antichi, le possibilità soffocate» (Bodei R., Ordo amoris. Conflitti terreni e felicità terrestri, Mulino, Bologna 1991, pag. 12).
Ma tutto ciò deve essere compiuto nel tempo in cui i segni della presenza di Dio sono difficilmente percepibili. Dio per lo più tace. Ciò che vediamo è il volto sofferente del suo Messia. Ma è in questo mistero - nel mistero della sofferenza, se volete, del fallimento di Dio - che è possibile fondare un'etica della solidarietà, se essa vuol essere veramente cristiana. Un'etica che sappia affermare, per vivere, la drammaticità della fedeltà di Dio all'uomo.
Forse nessuno come Bonhoeffer nel carcere dove attendeva la condanna, ha saputo esprimere questa situazione:
Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione,
implorano aiuto, chiedono felicità e pane,
salvezza dalla malattia, dalla colpa e dalla morte.
Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani.
Questo atteggiamento che fa parte del bagaglio religioso dell'umanità, deve essere capovolto. Continua Bonhoeffer:
Uomini vanno da Dio nella sua tribolazione,
lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane,
lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte.
I cristiani stanno vicini a Dio nella sua sofferenza.
E conclude:
Dio va da tutti gli uomini nella loro tribolazione,
sazia il corpo e l'anima con il suo pane,
muore crocifisso per cristiani e pagani,
e a questi e a quelli perdona.
Mario Cuminetti
http://www.pretioperai.it/index.php?option=com_content&view=article&id=282:licona-del-messia-sofferente&catid=107:1996-n34-immagini-di-dio&Itemid=79

Nessun commento:
Posta un commento