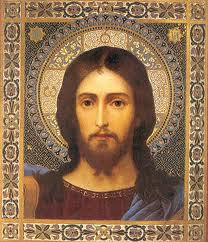 L'esperienza del limite è forse molto più forte oggi che in altri tempi. I continui progressi nei diversi campi della tecnica e soprattutto in quello della medicina e della genetica rendono più acuta la percezione della necessità di superarlo. Essi, infatti, fanno intravvedere grandi possibilità di sempre nuove conquiste ed alimentano sogni di un sempre più sicuro e perfetto futuro dell'umanità. Queste prospettive, indirettamente, alimentano i conflitti esistenziali di cui è intessuta la vita di ognuno, nutrita com'è di desideri e di paure, di aspirazioni e di delusioni. Si ha il desiderio di volare e la paura di cadere, il desiderio di vivere e la paura di morire, il desiderio di amare e di essere amati e la paura di tradire e di essere traditi. L'avanzamento della tecnica non ha diminuito, bensì acuito le incertezze, non ha eliminato, ma moltiplicato le ragioni dell'angoscia esistenziale. Ora, proprio questa esperienza del limite, che produce incertezza e angoscia, sfida l'antropologia cristiana a trovare delle coordinate concettuali per vivere il limite in modo umano, sia quando lo si considera valicabile che quando lo si considera invalicabile. In effetti, esistono limiti che sono invalicabili, perché la loro conservazione protegge e garantisce l'umanità dell'uomo, e limiti valicabili, perché il loro superamento contribuisce a promuovere la medesima umanità di ogni uomo. L'antropologia cristiana è, comunque, chiamata a fornire motivazioni ed orientamenti sia per rispettare i primi che per superare i secondi. In effetti, il cristianesimo ha proposto un ideale di vita "perfetta", nell'indicare Dio stesso come il perfetto da imitare. La filosofia greca aveva elaborato il concetto di perfezione, che si ritrova alla base del pensiero metafisico e come una componente essenziale della spiritualità cristiana, con Parmenide prima e con Aristotele poi. Per Parmenide, la perfezione è la proprietà fondamentale dell'essere. Secondo Aristotele, è perfetto sia ciò di cui non si può concepire nulla di superiore, sia ciò che raggiunge il suo vero fine. Il cristianesimo ha attinto il concetto di perfezione dalla visione filosofica dei greci. Infatti, nel giudaismo, il concetto di perfezione è praticamente inesistente. Il mondo biblico non usa mai il termine "perfetto", per qualificare Dio. Non si dice mai che Jahweh è perfetto. Nell'Antico Testamento, si parla più di santità che di perfezione. Nel Nuovo Testamento, il termine "perfezione", nei Sinottici, lo si trova solo due volte in Matteo. La prima è in Mt 5, 48: "siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli", dove il termine "perfetto" sarebbe per altro un'ellenizzazione dell'aggettivo aramaico "misericordioso". La seconda volta è in Mt 19, 21: "se vuoi essere perfetto, va e vendi tutto quello che hai...". I paralleli di Marco e Luca riportano lo stesso detto con l'espressione: "Una cosa sola ti manca". Nel resto del Nuovo Testamento, il termine "perfetto" si trova 29 volte, di cui 13 nella letteratura paolina. Con il diffondersi del cristianesimo, il concetto di perfezione passò dalla sfera filosofico-metafisica a quella morale. Soprattutto con i Padri greci si creò una moralizzazione della perfezione. Il tema della perfezione occupa un posto centrale nelle omelie di Origene. La perfezione di Dio reclama la perfezione dell'uomo. Con la diffusione della vita monastica in Occidente, poi, la perfezione assume maggiormente un carattere ascetico. Diventa l'obiettivo fondamentale del vero cristiano. Tutte le energie di vita spirituale si concentrano nel motto: "Dio vuole che tutti siamo perfetti". L'uomo perfetto è l'uomo spirituale. Ora, è stata la creazione di questo mito della perfezione a portare, per lo meno indirettamente, alla perdita del senso del limite. La mistica della perfezione ha immaginato un ideale di uomo onnipotente. Il modello di uomo da raggiungere è quello che va oltre i propri limiti, ma senza rendersi conto che oltre il limite non c'è la perfezione, bensì la disumanizzazione. L'antropologia della perfezione serve soltanto a creare persone nevrotiche, ammalate. Infatti, ogni fallimento, ogni errore mette tutti profondamente in crisi. Ogni insuccesso è causa di traumi interiori. La pretesa che la vita sia perfetta diventa la pretesa che tutti siamo perfetti, e le persone vengono giudicate con il metro di misura della perfezione: è bravo, è intelligente, è riuscito.
L'esperienza del limite è forse molto più forte oggi che in altri tempi. I continui progressi nei diversi campi della tecnica e soprattutto in quello della medicina e della genetica rendono più acuta la percezione della necessità di superarlo. Essi, infatti, fanno intravvedere grandi possibilità di sempre nuove conquiste ed alimentano sogni di un sempre più sicuro e perfetto futuro dell'umanità. Queste prospettive, indirettamente, alimentano i conflitti esistenziali di cui è intessuta la vita di ognuno, nutrita com'è di desideri e di paure, di aspirazioni e di delusioni. Si ha il desiderio di volare e la paura di cadere, il desiderio di vivere e la paura di morire, il desiderio di amare e di essere amati e la paura di tradire e di essere traditi. L'avanzamento della tecnica non ha diminuito, bensì acuito le incertezze, non ha eliminato, ma moltiplicato le ragioni dell'angoscia esistenziale. Ora, proprio questa esperienza del limite, che produce incertezza e angoscia, sfida l'antropologia cristiana a trovare delle coordinate concettuali per vivere il limite in modo umano, sia quando lo si considera valicabile che quando lo si considera invalicabile. In effetti, esistono limiti che sono invalicabili, perché la loro conservazione protegge e garantisce l'umanità dell'uomo, e limiti valicabili, perché il loro superamento contribuisce a promuovere la medesima umanità di ogni uomo. L'antropologia cristiana è, comunque, chiamata a fornire motivazioni ed orientamenti sia per rispettare i primi che per superare i secondi. In effetti, il cristianesimo ha proposto un ideale di vita "perfetta", nell'indicare Dio stesso come il perfetto da imitare. La filosofia greca aveva elaborato il concetto di perfezione, che si ritrova alla base del pensiero metafisico e come una componente essenziale della spiritualità cristiana, con Parmenide prima e con Aristotele poi. Per Parmenide, la perfezione è la proprietà fondamentale dell'essere. Secondo Aristotele, è perfetto sia ciò di cui non si può concepire nulla di superiore, sia ciò che raggiunge il suo vero fine. Il cristianesimo ha attinto il concetto di perfezione dalla visione filosofica dei greci. Infatti, nel giudaismo, il concetto di perfezione è praticamente inesistente. Il mondo biblico non usa mai il termine "perfetto", per qualificare Dio. Non si dice mai che Jahweh è perfetto. Nell'Antico Testamento, si parla più di santità che di perfezione. Nel Nuovo Testamento, il termine "perfezione", nei Sinottici, lo si trova solo due volte in Matteo. La prima è in Mt 5, 48: "siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli", dove il termine "perfetto" sarebbe per altro un'ellenizzazione dell'aggettivo aramaico "misericordioso". La seconda volta è in Mt 19, 21: "se vuoi essere perfetto, va e vendi tutto quello che hai...". I paralleli di Marco e Luca riportano lo stesso detto con l'espressione: "Una cosa sola ti manca". Nel resto del Nuovo Testamento, il termine "perfetto" si trova 29 volte, di cui 13 nella letteratura paolina. Con il diffondersi del cristianesimo, il concetto di perfezione passò dalla sfera filosofico-metafisica a quella morale. Soprattutto con i Padri greci si creò una moralizzazione della perfezione. Il tema della perfezione occupa un posto centrale nelle omelie di Origene. La perfezione di Dio reclama la perfezione dell'uomo. Con la diffusione della vita monastica in Occidente, poi, la perfezione assume maggiormente un carattere ascetico. Diventa l'obiettivo fondamentale del vero cristiano. Tutte le energie di vita spirituale si concentrano nel motto: "Dio vuole che tutti siamo perfetti". L'uomo perfetto è l'uomo spirituale. Ora, è stata la creazione di questo mito della perfezione a portare, per lo meno indirettamente, alla perdita del senso del limite. La mistica della perfezione ha immaginato un ideale di uomo onnipotente. Il modello di uomo da raggiungere è quello che va oltre i propri limiti, ma senza rendersi conto che oltre il limite non c'è la perfezione, bensì la disumanizzazione. L'antropologia della perfezione serve soltanto a creare persone nevrotiche, ammalate. Infatti, ogni fallimento, ogni errore mette tutti profondamente in crisi. Ogni insuccesso è causa di traumi interiori. La pretesa che la vita sia perfetta diventa la pretesa che tutti siamo perfetti, e le persone vengono giudicate con il metro di misura della perfezione: è bravo, è intelligente, è riuscito.Nella classicità, la hybris, ossia lo sfrenato desiderio di potere e di piacere che porta a sfidare la natura viene punita dagli dei. La hybris è in rapporto con l'invidia deorum. L'uomo superbo, che crede di essere fatto da sé e di poter agire come un dio, nel disprezzo dei limiti naturali, rischia sempre l'invidia deorum, la punizione celeste. L'idea che Dio esalta gli umili e umilia i potenti percorre tutto il mondo classico. Anzi, è proprio questa la chiave della classicità: il senso del limite, rappresentato da Apollo. L'Apollo del santuario di Delfi. Il dio civilizzatore. Quello che impartisce insegnamenti come "conosci te stesso", e "nulla di troppo", che sono inviti alla moderazione. Apollo è il dio del limite inteso non come costrizione, ma come armonia, proporzione, bellezza. Il santuario di Delfi è il grande educatore dei greci alla civiltà: Apollo è infatti il dio delle leggi e perciò della libertà. La libertà, precisa Properzio, per l'uomo antico, non è quod libet licet. La libertà apollinea coincide con le leggi, e più precisamente con il diritto naturale: la ragione, la coscienza, la misura greca gli devono tutto. Le statue greche ci dicono che cosa fosse per i greci il limite come bellezza: le giuste proporzioni da cui traspare il divino. Per Epicuro, il piacere non consisteva negli eccessi ma nella moderazione. Dal punto di vista filosofico, le prime dure critiche ai deliri di grandezza della ragione si sono riscontrate nei primi del Novecento. La critica alla metafisica di Nietzsche, prima, e il tentativo del suo superamento, poi, da parte di Heidegger, la messa sotto accusa della cultura dell'illuminismo da parte dei filosofi della scuola di Francoforte, la scoperta del subconscio di Freud, la filosofia del linguaggio di Wittgenstein e l'ermeneutica di Gadamer hanno messo in crisi il primato dell'antropologia della perfezione, della filosofia dell'"io". Colui, comunque, che ha analizzato maggiormente la coscienza del limite dell'uomo come condizione per diventare "umani" fu senz'altro M. Heidegger. Il problema di fondo della sua filosofia, come si sa, era quello di capire il senso dell'esistenza dell'uomo. Per Heidegger, il punto di partenza per un'esistenza autentica è la presa di coscienza dell'intrinseca finitezza dell'essere. Il limite invalicabile della sua finitezza è
segnato dalla morte. Ciò che ci umanizza, che ci fa prendere coscienza dei nostri limiti, è "l'essere per la morte". Fino a una certa età, ci si sente eterni. La morte, la fine è qualcosa che avviene fuori di noi. Per tutti, però, c'è un momento in cui si prende coscienza che "anch'io muoio". Anche il mio "io" finisce. La morte non riguarda più soltanto gli altri, ma è una realtà che fa parte di me. La presa di coscienza della nostra morte da immortali ci rende mortali. "Essere per la morte", tuttavia, non vuol dire che si vive per morire. La vita è vita, e non è finalizzata alla morte. La vita, però, è se stessa, cioè è autentica, quando tiene conto che è destinata a finire. Allora, la morte non è la fine o il momento ultimo dell'esistenza, ma è ciò che conferisce serietà all'esistenza. L'accettazione del limite radicale che è la morte comporta l'adozione di una nuova antropologia, che passi dall'ideale della perfezione, che è stato alla base di tutta la cultura occidentale, all'ideale di un uomo limitato. All'umanesimo dell'autoesaltazione bisogna contrapporre un umanesimo dell'autoaccetazione. Ciò comporta che si deve passare da un sistema mentale che considera l'errore, l'insuccesso, il limite come nemico della vita, ad una cultura che considera il limite come un dato, che fa parte essenziale dell'esistenza e costituisce la materia prima della vita. Il limite è una realtà che non si puà evitare. Non è qualche cosa che è posto dall'uomo, ma qualcosa che è imposto all'uomo. Dal punto di vista scientifico, sono numerosi gli enigmi che la scienza deve risolvere per costruire una ragionevole conoscenza della realtà. I curatori della rivista Science, organo dell'"American Association for the Advancement of Science", per celebrare i 125 anni della nascita della pubblicazione, hanno condotto un'indagine tra i ricercatori esaminando 125 grandi domande ancora senza risposta sui loro tavoli. La conclusione ha portato a concentrare l'attenzione su 25 ricerche giudicate più urgenti, dalle quali sono uscite cinque domande che avranno forse la possibilità di essere risolte nei prossimi 25 anni.
La prima domanda è: di che cosa è formato l'universo?
La seconda: quali sono le basi biologiche
della coscienza?
La terza: perché l'uomo ha così pochi geni?
La quarte: quanto può essere allungata la vita umana?
La quinta si chiede se la terra potrà sostenere la crescita della popolazione.
Nel proporre un'antropologia del limite, a scanso di equivoci, è necessario anzitutto fare una precisazione. Giustificare e valutare positivamente l'accettazione del limite umano equivale a proporre un'etica dell'infinito. Non equivale, quindi, a proporre un atteggiamento di rassegnazione, una sorta di stoico fatalismo, che si traduce in un'etica di corto respiro, in un'etica del finito. Questo genere di etica non soddisfa le aspirazioni più profonde dell'uomo. S. Agostino, a suo tempo, aveva definito l'etica del finito e del possibile come un'etica dell'infelicità: "E' questo, dicono, il sapiente
consiglio di Terenzio: "poiché non ti è possibile realizzare ciò che vuoi, desidera ciò che puoi" (Andria II, 1, 5-6). Nessuno può negare che queste parole siano molto sagge, ma non può negare che siano un consiglio dato a un infelice, perché non sia ancora più infelice." L'accettazione del limite, dunque, non è una scelta di rassegnazione. E' una scelta di buon senso, che accetta nella propria vita la presenza di un altro, ed è una scelta di fede, che, sempre nella stessa vita, accetta la presenza di un Altro, sia nel suo inizio che nella sua fine. La vita non ci appartiene. Essa non ha avuto inizio quando lo abbiamo deciso noi, e non ha termine neppure quando lo stabiliamo noi. L'esistenza umana è come la volta del firmamento sulla quale appendiamo le stelle dei nostri desideri e dei nostri progetti, la tela sulla quale disegniamo i contorni del nostro futuro. Ma questo firmamento, questa immensa tela celeste sulla quale disegniamo il mosaico della nostra vita e della nostra felicità ci sono stati concessi solo in prestito. Non ci appartengono. Questo è il limite fondamentale della creaturalità, che include tutti gli altri limiti, i quali, in qualche modo, sono da esso derivati. Se si accetta questo limite fondamentale, si accettano anche gli altri limiti ad esso a vario titolo connessi. Possiamo affermare che, secondo una prospettiva di semplice ragione, l'uomo è ciò che diviene, e, secondo questa prospettiva, egli non accetta la presenza di un Altro nella propria vita. Egli non conosce altro punto di partenza, per i suoi progetti e per i suoi orientamenti esistenziali, che la propria autonoma esistenza. Secondo una prospettiva di fede, invece, l'uomo diviene ciò che è. In questo caso, egli accetta che all'inizio della sua vita ci sia il disegno di un altro. Questo disegno non è attinto nel campo dell'esperienza umana, ma affonda le sue radici nell'eternità, nel cuore stesso di Dio. Divenire ciò che si è significa accettare di realizzare il progetto di un altro, nella convinzione che, nella misura in cui si accetta il progetto di un altro, si accetta il proprio progetto, si è fedeli a se stessi, si realizza se stessi. E' proprio vero che per essere se stessi, bisogna essere di un Altro. Ciò significa, però, che non basta essere per vivere, ma bisogna vivere per essere.
Si può paragonare il rapporto tra il divenire ciò che si è ed essere ciò che si diviene al rapporto che intercorre tra un esodo ed un avvento. L'esodo è un itinerario per raggiungere la meta, la quale, pure se è stata prefissata da un Altro, costituisce sempre una terra promessa. Il fatto che la meta sia stata prefissata da un Altro, e nel nostro caso specifico da Dio, è certamente un limite della propria libertà. Dover raggiungere solo quella determinata meta vincola la libertà di scelta, costituisce un limite, perché ciò elimina altre mete da raggiungere e, soprattutto, elimina la possibilità di stabilire delle mete proprie. L'avvento, invece, è l'irruzione di qualcosa di totalmente nuovo ed impensato nella propria vita. Esso è l'abbreviazione dell'avventura, è la porta d'ingresso nell'incognito, nel quale si gioca da soli e si scommette sul proprio destino, nel silenzio della propria coscienza e nella solitudine della propria responsabilità. In ultima analisi, la vita umana è un disegno a quattro mani: le due mani invisibili di Dio e le due mani visibili dell'uomo. Insieme esse disegnano una vita, che è frutto di due amori ed opera di due libertà. Le mani di Dio non operano da sole. Ma nemmeno le mani dell'uomo operano da sole. Dio
opera per mezzo dell'uomo, e l'uomo agisce sotto la guida invisibile di Dio. Il mosaico che risulta da questa duplice paternità è contemporaneamente aperto al futuro di Dio e alla libertà dell'uomo. Questa duplice paternità, però, non è facile da accettare e costituisce uno dei più forti misteri della vita umana. Infatti, in base a questa duplice paternità, l'uomo è soggetto ed oggetto allo stesso tempo: soggetto della sua risposta di libertà, oggetto della chiamata creatrice di Dio. La differenza che esiste tra soggetto e oggetto, tra il progetto stabilito dal cuore di Dio e la sua attuazione da parte del cuore dell'uomo, tra quello che si è in realtà e quello che si vorrebbe essere secondo il proprio desiderio, si traduce indirettamente in una nostalgia della trascendenza. Il differire della perfezione nel tempo e il differire dalla perfezione nella concretezza della vita segna la distanza che intercorre tra l'eternità e la storia, tra l'infinito e il tempo, tra Dio e l'uomo. Esso, qualora sia vissuto ed accolto positivamente, contribuisce ad acuire il desiderio e la nostalgia della patria futura più che ad alimentare la rassegnazione del tempo presente.
Quali sono i limiti che possono essere considerati invalicabili e che devono essere accettati come tali per essere "vissuti" cristianamente? Se ne possono esemplificare alcuni. Il dolore è senz'altro un limite invalicabile, una realtà ineludibile, un'esperienza universale. Quando esso diventa sofferenza, quest'ultima può essere senz'altro orientata a seconda delle convinzioni personali circa la vita e la morte. Orientare la sofferenza non significa, tuttavia, eliminare il dolore, perché esso è ineliminabile. Significa solamente affrontarlo con motivazioni che non provengono direttamente dall'esperienza umana e che sono, invece, ancorate alla Parola di Dio. La Parola di Dio illumina l'intelligenza e muove il cuore, ma non elimina la drammaticità della vita. La domanda del profeta Isaia nella descrizione drammatica dell'occupazione di Babilonia: "sentinella, quanto durerà ancora la notte"? e la risposta ad essa: "Verrà il mattino, ma è ancora la notte" (Isaia, 21, 11-12) mette in chiara evidenza che la speranza dell'alba non toglie niente al buio della notte.
Un altro limite invalicabile delle nostre possibilità e dei nostri desideri è lo stesso corpo umano. Noi lo riceviamo alla nascita; non lo costruiamo a nostro piacimento. Esso si sviluppa secondo un suo programma del DNA, che non è modificabile se non in minima parte dall'integrazione dell'ambiente. Il corpo introduce ogni singolo uomo e ogni singola donna nel consorzio umano, dando a ciascuno una precisa e insostituibile identità, fatta di una determinata statura, di un colore della pelle, di tutti quei particolari che distinguono una razza da un'altra. Esso è fragile, è debole, è continuamente esposto alla malattia. Non è possibile, infatti, non ammalarsi, perché ciò fa parte della natura umana. La malattia è un limite valicabile e va perciò combattuta con tutte le forze, ma l'ammalarsi rimane sempre un limite invalicabile. Il corpo non è una macchina a disposizione dei propri desideri, ma corrisponde al proprio intimo essere. Ognuno è il suo corpo, non solo ha un corpo. Uno dice: io sono stanco, io ho fame, non: io ho un corpo stanco, io ho un corpo che ha fame. Il corpo non può essere ridotto al solo "organismo" che le pratiche mediche, generando un
chiaro senso di dissociazione, possono trattare come un qualsiasi oggetto di natura, come una qualsiasi materia prima. Se il processo di materializzazione in atto nel campo della scienza e soprattutto della tecnica non fa più coincidere l'io interiore di un uomo con il suo corpo, ma si serve del corpo dell'uomo come di uno strumento a sua disposizione, in ultima analisi fa cadere ogni differenza tra l'uomo e le cose. Ciò, però, renderebbe difficile, se non proprio impossibile, trovare un criterio per riconoscere l'uomo e distinguerlo dalle cose e dagli oggetti.
Un altro limite ancora, per certi versi invalicabile, è la realtà sociale e culturale che ci circonda. Essa solo in parte è frutto delle nostre scelte e delle nostre decisioni. L'ambiente fisico ed umano nel quale viviamo e del quale abbiamo bisogno per vivere non è costruito da noi, bensì ereditato. Accettare il limite della realtà, allora, significa viverla e gestirla come essa si presenta e non sostituirla con delle rappresentazioni di essa. Talvolta potrebbe essere più facile, per esempio, teorizzare una società perfetta, sognare una specie di paradiso terrestre. Ma le tragiche smentite della storia richiamano tutti alla dura realtà. La malizia che si annida nel cuore dell'uomo e che ha inventato tanti inferni di sofferenza, fa prendere coscienza che il mondo reale in cui si vive è molto diverso da quello ideale che si sogna.
Se, ora, come abbiamo detto, l'accettazione del limite umano sfocia in un'etica dell'infinito, come bisogna proporre quest'etica dell'infinito a partire dal limite? In altri termini, è realmente possibile avere un'etica dell'infinito a partire dal finito? E' mia convinzione che ciò sia possibile, e vorrei esporre qualche riflessione a questo riguardo. A ben considerare, il limite, in se stesso, è una percezione dell'infinito. L'infinito è la sua luce e la sua misura. Il limite non chiude ma apre il futuro, non umilia ma esalta la libertà. La tradizione cristiana ha collocato la perfezione dell'uomo alla fine e non all'inizio della sua esistenza. La già menzionata legge del progresso, illustrata e difesa dai Padri del II-III secolo, fu uno degli argomenti cardine della lotta contro le teorie degli gnostici. Adamo veniva considerato come un bambino che doveva crescere e maturare. Quello che contava era il profectus cui egli era destinato. E' il profectus, infatti, che apre la vita alle realizzazioni future, che trasforma l'inquietudine del cuore nel dinamismo dello spirito. Il limite, nel momento in cui è accettato come limite, non è più limite, è superato. Se esso è gestito come un limite, diventa un non-limite, ed è automaticamente superato e superabile.
Le coordinate necessarie per strutturare questa etica dell'infinito sono offerte dall'antropologia cristiana dell'immagine. L'immagine, infatti, in se stessa, è un limite. Non è l'archetipo, non è l'originale. Ma essa è sempre in rapporto con l'archetipo e con l'originale. La creatura è sempre in rapporto con il Creatore. L'uomo immagine è in se stesso un limite. Un limite verso l'alto, perché non è Dio, è un essere che sfida gli dei, secondo Eschilo, un essere che parla degli dei, secondo Platone, un essere che parla a Dio, secondo S. Agostino. E' dalla parte di Dio. E' vicino a Dio, parla con Lui, sfida il suo divieto, ma non è Dio. Però è immagine di Dio, cioè deriva da Dio, dipende da
Dio. Per capire l'uomo bisogna partire da Dio. L'immagine ha in se stessa qualcosa di fragile, di debole, di corruttibile, ma allo stesso tempo ha una valenza di eternità. Essa respinge sia il dualismo ontologico, che divide l'uomo in due sostanze, che il monismo materialistico, che lo riduce alla sola materia, al cosiddetto uomo neuronale. L'uomo è immagine di Dio in tutta la sua realtà fisica e spirituale, ed è, a priori, un essere responsabile verso Dio e creato per Lui. Proprio in base a questa sua somiglianza divina, che costituisce la sua vera dignità, egli è fondamentalmente diverso da tutto il mondo infraumano. Il punto di partenza per l'etica dell'infinito promossa dall'antropologia dell'immagine è il limite più significativo della storia umana: l'incarnazione del Figlio di Dio. Lo specifico della tradizione cristiana è, infatti, l'umanazione di Dio, chiamata dall'evangelista Giovanni "incarnazione", cioè il divenire ciò che è più lontano da Dio, il divenire carne, ossia ciò che accomuna l'uomo con l'animale, ciò che è destinato alla corruttibilità, alla morte. La storia umana ha accettato miti in base ai quali un uomo è diventato dio, perché questa possibilità esalta la potenza dell'uomo, ma non ha trovato facile ammettere che un Dio diventi uomo, perché questa eventualità deprime la potenza di Dio. La difesa dell'umanità di Gesù è stata molto più difficile della difesa della sua divinità. Ora, Gesù ha assunto il limite umano, per superarlo dal di dentro. Ha assunto l'umanità per divinizzarla, per seminare in ogni suo frammento germi nascosti di eternità. Gesù, nell'accettare il limite della natura umana, ha trasformato questa natura umana in una promessa di salvezza. Dopo l'evento della sua risurrezione, la promessa di salvezza umana non è più un'utopia. La risurrezione di Gesù dai morti ha offerto una prolessi di questa salvezza, trasformando l'utopia in speranza, l'"occidente" in "oriente", la morte in vita.
http://www.ignaziosanna.com/files/antropologia_del_limite.pdf

Nessun commento:
Posta un commento