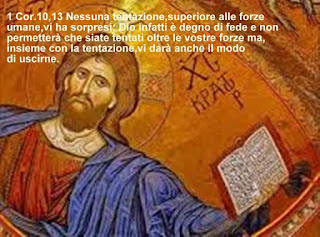 La domanda del dolore ci interroga tutti: per questo, forse, il Cristo sofferente -
La domanda del dolore ci interroga tutti: per questo, forse, il Cristo sofferente -quello della passione e della morte in Croce, quello della Sindone - raggiunge più
facilmente il cuore di ciascuno di noi. Dall’evidenza del dolore muoviamo per
avvicinarci al Vangelo del Dio Crocifisso e cogliere per quanto possibile alla luce della
“passio Christi” il senso e il valore della “passio hominis”. È la via suggerita dalla
bellissima poesia di Giuseppe Ungaretti:
Fa piaga nel Tuo cuore
La somma del dolore
Che va spargendo sulla terra l’uomo;
Il Tuo cuore è la sede appassionata
Dell’amore non vano.
Cristo, pensoso palpito,
Astro incarnato nell’umane tenebre,
Fratello che t’immoli
Perennemente per riedificare
Umanamente l’uomo,
Santo, Santo che soffri,
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,
Santo, Santo che soffri
Per liberare dalla morte i morti
E sorreggere noi infelici vivi,
D’un pianto solo mio non piango più,
Ecco, Ti chiamo, Santo,
Santo, Santo che soffri1.
Il dolore - “la somma del dolore che va spargendo sulla terra l’uomo” e quello per
cui il Figlio è venuto nella carne a “liberare dalla morte i morti / e sorreggere noi infelici
vivi” - è veramente la categoria universale, che accomuna tutti: “Gli uomini si
distinguono gli uni dagli altri nel possesso, ma sono solidali nella povertà” (Jürgen
1 G.Ungaretti, da Mio fiume anche Tu, in Id., Vita d’n uomo. Tutte le poesie, Milano 198812, 229s.
2
Moltmann). La storia sembra avanzare attraverso il dolore, nei conflitti di interessi, di
classi, di individui e di popoli. Si potrebbe parlare di essa come della “storia delle
sofferenze del mondo”. Dal profondo dell’ingiustizia si leva la domanda angosciosa sul
senso di tutto questo e l’aspirazione alla giustizia, la cui assenza e nostalgia è il pungolo
supremo del dolore. È il problema di Dio. “Si Deus iustus, unde malum?”, se c’è un Dio
giusto, perché c’è il male? e se c’è il male, come potrà esserci un Dio giusto? Dalle
piaghe della storia nasce così il rifiuto o l’invocazione del totalmente Altro.
Alcuni, dinanzi all’inconciliabilità di Dio e del male, sopprimono il primo dei due
termini: è la soluzione dell’ateismo tragico. “Per Dio la sola scusa è che non esiste”
(Stendhal e Nietzsche). “Se Dio esiste, il mondo è la sua riserva di caccia” (parole di un
ateo in un romanzo di Luigi Santucci). “Gli occhi che hanno visto Auschwitz e
Hiroshima, non potranno più contemplare Dio” (Hemingway). In realtà, però, ridurre
tutto a questo mondo e alle sue leggi, significa arrendersi di fronte al problema del
dolore e della morte. Altri risolvono il conflitto attraverso la fede in un Dio che tutto
regola in vista del bene, secondo disegni che la mente umana non può capire: è la
soluzione degli amici di Giobbe, che resta però insoddisfatto, sorretto dalla struggente
attesa di una giustizia futura: “Io lo so che il mio Vendicatore è vivo e che, ultimo, si
ergerà sulla polvere! Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò
Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero” (Gb
19,25-27). Una fede in Dio, che giustificasse la sofferenza e l’ingiustizia del mondo
senza avvertirne lo scandalo, rischierebbe di essere disumana e di produrre frutti
satanici. La rassegnazione è abdicazione di fronte al compito di cambiare l’ingiustizia
del mondo. Altri, infine, identificando nella sete di giustizia la radice ultima del dolore,
tracciano un sentiero di rinunce, che porti ad estinguere ogni sete e perciò ogni capacità
di amare e di soffrire: è la soluzione di alcune mistiche orientali, che oggi sembrano
suscitare un singolare fascino nei paesi dell’Occidente; soluzione, che però riduce la
storia umana a vuota impermanenza, e la vita alla fuga verso un “nirvana”, che lascia
intatte le lacerazioni e le piaghe della sofferenza del mondo.
Di fronte all’incompiutezza di queste proposte sta la “pretesa” cristiana di
salvezza nel Dio crocifisso: che senso ha l’evento della Croce per la sofferenza del
mondo? Che cosa è accaduto in quel Venerdì Santo per la storia del mondo? E quale
esperienza del dolore umano ha avuto il Figlio di Dio venuto nella carne? Si sono
presentati nella storia di Gesù di Nazaret l’oscurità e la lacerazione del negativo, che
diffondono un odore di morte su tutta la vita? o, in forza della sua condizione divina, il
Nazareno non ha conosciuto la fatica di vivere, il peso dell’ostilità delle cose e degli
uomini, la resistenza interiore di fronte alla tenebra e alla prova? Per rispondere a questi
interrogativi, dobbiamo accostarci, con la discrezione e il pudore doverosi di fronte a
ogni esperienza di finitudine e tanto più necessari davanti alla sua, al suo cammino verso
la croce, fino all’ora oscura della sua morte ed a ciò che essa rivela riguardo al mistero
divino e alla salvezza degli uomini. È il Vangelo delle sofferenze...
1. Il Vangelo delle sofferenze
Si può dire che tutta la vita di Gesù è orientata alla croce: le stesse narrazioni
3
evangeliche si presentano come “storie della passione, con un’introduzione
particolareggiata” (Martin Kähler). I “giorni della sua carne” (cf. Eb 5,7) stanno senza
eccezione sotto il segno grave e doloroso della croce: “Tutta la vita di Cristo fu croce e
martirio” (Imitazione di Cristo, l. II, cap. 12). Da quando l’annuncio cristiano risuona
nel tempo, il racconto della storia di Dio fra gli uomini è indissolubilmente unito a
“quella passione, che è la storia della sua vita” (Kierkegaard), il Vangelo delle sue
sofferenze. Non si capirà la vita di Gesù senza la croce, come non si capirà la croce
senza il cammino verso di essa. È perciò che la comunità delle origini ha potuto
riconoscere nel Nazareno “l’uomo dei dolori” di cui parla il Profeta (cf. Is 53,3): “Come
una pecora fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,
così egli non aprì la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato...” (At
8,32-33). Gesù di Nazaret è il Servo, l’Innocente che soffre per puro amore sotto il peso
dell’ingiustizia del mondo!
È giustificata una simile lettura delle opere e dei giorni del Nazareno? Gli
evangeli sono molto discreti su questo punto: la loro testimonianza non ha niente di
emotivo o di passionale. Essa consente tuttavia di intravedere nella vicenda del Profeta
galileo almeno tre livelli dell’esperienza umana del dolore: il livello della finitudine
fisica, quello della finitudine psicologica ed infine il livello della sofferenza morale e
spirituale. Gli Evangelisti non nascondono gli aspetti umanissimi della finitudine fisica
di Gesù: la sua fame (cf. Mt 4,2: “Gesù ... ebbe fame”; Lc 4,2), la sua sete (cf. Gv 19,28:
“Ho sete”), il sonno (cf. Mc 4,38 e par.: “Gesù se ne stava a poppa, sul cuscino, e
dormiva”). Il grido di Gesù morente (cf. Mc 15,34) è peraltro segno di una straziante
sofferenza anche sul piano fisico. L’importanza di questi rilievi - all’apparenza
marginali - non sta solo nella garanzia di storicità che contribuiscono a dare al racconto
(chi avrebbe inventato tratti così ordinarie perfino scandalosi della figura di Colui che
veniva annunciato come il Cristo?), ma anche nel valore che implicitamente vi annette la
comunità delle origini: contro ogni riduzione doceta - tendente sin dall’alba del
cristianesimo a salvaguardare la divinità del Figlio diminuendo la consistenza della sua
umanità - la fede pasquale ha cura di sottolineare la verità dell’incarnazione, quella per
la quale alla nostra carne è offerta e promessa salvezza nella carne del Redentore
dell’uomo. Non a caso grandi mistici e santi hanno messo al centro delle loro attenzioni
la fisicità di Gesù, con tutta la verità dei suoi condizionamenti e dei suoi limiti:
dall’amore alle piaghe del Signore, venerate tanto appassionatamente da San Francesco
da riceverle nella propria carne, alle invocazioni di Sant’Ignazio (“Corpo di Cristo,
salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di
Cristo, confortami... Dentro le Tue piaghe, nascondimi”), alla tenerezza del Bambino
appena nato, cantata da Sant’Alfonso de’ Liguori. Veramente, il cristianesimo non è la
religione della salvezza dalla storia, ma della salvezza della storia: nessuno spiritualismo
disincarnato è giustificato per i discepoli di Colui, che l’alto Medio Evo amava
designare come “Dominus humanissimus”...
La discrezione dei Vangeli rispetta ancor più il silenzio sulla finitudine interiore
sperimentata da Gesù, interrompendolo appena con segni e richiami improvvisi,
rivelatori di una sua familiarità con i limiti della condizione umana e con il dolore.
Emerge, così, qualche tratto dell’esperienza da lui fatta della finitudine psicologica:
4
Gesù cresce “in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini” (Lc 2,52),
passando dunque da un livello presente, ma implicito, ad un livello sempre più
tematizzato ed esplicito della sua coscienza umana di Figlio. Questa “messa in
parentesi” della sua conoscenza divina è un aspetto della più generale “kénosi” a cui lo
ha spinto liberamente il suo amore per gli uomini (cf. Fil 2,6ss), e spiega come nel
cammino della sua autocoscienza di uomo ci siano zone d’ombra, su cui egli sente il
bisogno di far giungere continuamente la luce e il conforto del dialogo col Padre nella
preghiera. Il peso che egli avverte dinanzi al presentito, lacerante futuro di dolore e di
morte, si lascia intravedere nei segni di quella che Origene chiamava con amoroso
pudore l’“ignorantia Christi”: così, mentre mostra di ignorare il giorno del giudizio (cf.
Mc 13,32 e Mt 24,36), come anche semplici fatti della vita quotidiana (ad esempio in
Mc 5,30-33, avvertita la potenza che era uscita da lui, chiede: “Chi mi ha toccato il
mantello?”), Gesù nel Getsemani prega perché gli sia risparmiato il calice della passione
(cf. Lc 22,42 ). La sua anima è “turbata” (Gv 12,27): è “in preda all’angoscia ... e il suo
sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra” (Lc 22,44), pur essendo il
suo cuore totalmente consegnato al Padre nella preghiera.
Gesù insomma - non diversamente da quanto avviene per ogni essere umano -
cresce alla scuola del dolore, come ci assicura l’Autore della Lettera agli Ebrei: “Nei
giorni della sua carne egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui
che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò
tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì” (5,7s). Tutto questo, certamente, nulla toglie
alla conoscenza straordinaria e profetica di cui in tanti momenti appare dotato (così ad
esempio in Gv 6,71 e 13,11 in riferimento al tradimento di Giuda; in Mc 2,6-8 in
rapporto ai pensieri nascosti degli scribi; in Mc 11,2, in riferimento ai prossimi eventi
della Pasqua; così, nei molteplici “vaticinia passionis”: Mc 8,31; 9,31 e 10,33ss; ecc.):
nei tratti umanissimi in cui si mostra l’esperienza di una certa finitudine psicologica si
rivela, però, in maniera peculiare la partecipazione reale del Cristo alla nostra
condizione umana, il suo essere veramente compagno del nostro dolore, tante volte
legato all’esperienza dell’oscurità davanti al domani e al mistero dell’altrui sofferenza. È
proprio per aver conosciuto questa condizione che egli può venirci in aiuto come “causa
di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono” (Eb 5,9).
Gesù conosce infine l’esperienza della sofferenza sul piano morale e spirituale: di
fronte alla morte dell’amico non trattiene il pianto (cf. Gv 11,35), manifestando il dolore
che solo l’amore conosce: “Vedete come lo amava!” (11,36). Al pensiero dell’ora vicina
della fine, la sua anima è “triste fino alla morte” (Mc 14,34), d’una tristezza che rivela il
suo attaccamento alla vita e che fu ed è di conforto a innumerevoli ore di tristezza
umana (si pensi solo a San Tommaso Moro, che in attesa della morte ingiustamente
subita trova forza scrivendo un “De tristitia animae Christi”!). Sullo sfondo di questa
continua discrezione appare ancora più violento il forte grido della croce: “Mio Dio,
Mio Dio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34): segno dell’abisso di un infinito
dolore? Gesù, in realtà, ha sentito la soglia imponderabile e amara della morte: la storia
della sua libertà, il suo continuo esodo da sé per amore del Padre e degli uomini, la sua
vita di preghiera, il cammino cosparso di prove della sua esistenza terrena ne sono la
conferma costante. Oscurità e tentazione si sono scontrate nel profondo del suo spirito
5
con l’incondizionata dedizione al Padre, che ne è stata come sigillata, fino al “sì” che lo
ha portato alla morte: “Abba, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo
calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu!” (Mc 14,36). Questa interiore
esperienza di finitudine, questa fatica di vivere assunta nella forza di un più grande
amore e della speranza riposta nel Padre suo, apre Gesù alla comprensione reale del
patire umano: la sua compassione per la folla (cf. ad esempio Mt 9,36; 15,32), il suo
commuoversi davanti agli infelici e ai sofferenti (cf. Mc 1,41; Mt 20,34; Lc 7,13; ecc.),
rivelano una sensibilità all’altrui dolore, che solo chi del dolore ha fatto esperienza
riesce ad avere. Il Sofferente, che comprende e ama, dà ristoro e forza a chi è oppresso
dal patire: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è
leggero” (Mt 11,28-30).
All’esperienza dell’interiore finitudine e alla compassione che ne deriva per
l’altrui soffrire, si aggiunge nella vita del Nazareno l’impatto durissimo col dolore
provocatogli dagli uomini: considerato un esaltato dai suoi (“È fuori di sé”: Mc 3,21),
accusato di essere un indemoniato dagli scribi (cf. Mc 3,22 e par.), definito un impostore
dai potenti (cf. Mt 27,63), egli sente tutto il peso dell’ostilità che si accumula nei suoi
confronti. Non è rattristato per le accuse, ma per la durezza dei cuori, da cui esse
provengono (cf. Mc 3,5). Gli avversari non si stancheranno di attaccarlo in tutti i modi:
la sua inaudita pretesa li irrita (cf. Mc 6,2-3; 11,27-28; Gv 7,15; ecc.), la sua popolarità
li spaventa (cf. Mc 11,18; Gv 11,48; ecc.). Gesù mette in discussione con la parola e con
la vita le loro certezze, e, col suo successo fra il popolo, rischia di scuotere dalle
fondamenta il precario ordine esistente. Ma egli è troppo libero per fermarsi sotto il
condizionamento della paura: continua perciò per la sua strada, nella fedeltà al “sì”
radicale detto al Padre. Si fa, è vero, accorto: riesce a sfuggire ai tentativi di lapidazione
e di arresto (cf. Lc 4,30; Gv 8,59; 10,39); evita occasioni di scontro (cf. Mc 7,24; 8,13;
ecc.). Gesù non ha nulla dell’eroe romantico, un po’ esaltato e un po’ incosciente. Egli
sa e mette a fuoco nel crogiuolo di questa sofferenza la scelta, che segnerà la svolta dei
suoi giorni terreni: il viaggio decisivo a Gerusalemme. “La città del gran Re” (Mt 5,35)
è il luogo dove i destini d’Israele e dei profeti devono compiersi (cf. Lc 13,33). Gesù
prevede ciò che l’aspetta a Gerusalemme come conseguenza della radicalità della sua
vita e del suo messaggio: il rifiuto incontrato in Galilea, ben più profondo dei facili
entusiasmi della folla, gli ha consentito di tematizzare senza più ombre che egli dovrà
bere fino in fondo il calice del destino del giusto. In questo senso, è la “crisi” che
attraversa tutta la “primavera galilaica” a portarlo a Gerusalemme: essa è una dolorosa
esperienza di finitudine, assunta però in un più chiaro slancio di donazione al Padre e di
fede nella finale vittoria della giustizia e dell’amore. Sarà questa opzione di obbedienza
totale, più forte di ogni sconfitta, che lo porterà infine incontro alla morte di croce.
Con l’andata a Gerusalemme si entra in pieno nella storia della passione. Gesù vi
si dirige “decisamente” (Lc 9,51: letteralmente: indurì la faccia per andarvi),
camminando avanti ai suoi, che lo seguono sconcertati (cf. Mc 10,32). Nella città di
Davide lo scontro raggiunge il suo apice: sono ormai coinvolti da vicino il Sinedrio e la
nobiltà laica e sacerdotale che esso rappresenta. Il Nazareno è consapevole dell’iniquità
6
che sta per consumarsi riguardo a lui, ma l’affronta con la ricchezza di senso di chi vede
la morte ingiustamente subita come una volontaria donazione, vissuta in obbedienza al
Padre e feconda di vita: ne sono prova i racconti dell’Ultima Cena, nei quali il Servo
confida ai suoi il memoriale dell’alleanza nuova nel suo sangue. In questo quadro di
finitudine, fonte di sofferenza liberamente accolta, viene a situarsi anche la vicenda del
processo di Gesù: è l’ora degli avversari, “l’impero delle tenebre” (Lc 22,53). Per quali
motivi è stato condannato il Nazareno? Agli occhi del Sinedrio egli è il bestemmiatore
(cf. Mc 14,53-65 par.), che con la sua pretesa e la sua azione (soprattutto la “scandalosa”
purificazione del tempio: cf. Mc 11,15-18 e par.) ha meritato la morte secondo la Legge
(cf. Dt 17,12). E tuttavia Gesù non ha subito la pena riservata ai bestemmiatori, la
lapidazione (cf. Lv 24,14): egli è stato giustiziato dagli occupanti romani, subendo la
pena inflitta agli schiavi disertori e ai sobillatori contro l’impero, l’ignominiosa morte di
croce. La sua condanna è stata, alla fine, politica, come attesta il “titulus crucis”, la
scritta con la motivazione della condanna posta sul palo della vergogna: “Gesù
Nazareno Re dei Giudei” (Gv 19,19). La sua morte è per la Legge il giorno in cui muore
il bestemmiatore e per il potere il giorno in cui muore il sovversivo. La fede pasquale vi
riconoscerà il giorno in cui, nell’Innocente che muore, è il Figlio di Dio che si è
consegnato alla morte per noi.
Meditando su questo “Vangelo delle sofferenze” del nostro Maestro e Signore,
non possiamo non interrogarci su come noi viviamo la nostra quotidiana esperienza del
limite e l’inevitabile incontro col dolore, che segna la vita nostra ed altrui. Sappiamo che
il discepolo non è da più del Maestro: se lui ha sofferto, come potremmo noi evitare la
via del dolore? Potremmo dire come Paolo: “Sono lieto delle sofferenze che sopporto
per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del
suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24)? Il timore e tremore delle nostre possibili risposte
può essere superato con l’unica certezza sulla quale è possibile rischiare tutto: la
certezza della fede. Il Maestro dà ciò che chiede e mai ci prova senza offrirci la via
d’uscita: egli è con noi nell’ora del dolore e ci aiuta a sopportare ed offrire le nostre
sofferenze. Ne è talmente convinto Ignazio di Loyola da non esitare a indicarci nella
sequela di Gesù in cammino verso la Croce tre gradi di umiltà, di cui il terzo è la meta
perfetta a cui tendere in compagnia del Salvatore: “Il primo modo di umiltà ... consiste
nell’ubbidire in tutto alla legge di Dio, nostro Signore ... Il secondo è non volere e
bramare d’esser ricco piuttosto che povero, onore piuttosto che disonore, di non
desiderare una vita lunga piuttosto che breve... La terza è umiltà perfettissima e si ha
quando ... per imitare e somigliare più concretamente a Cristo nostro Signore, io voglia e
scelga piuttosto la povertà con Cristo che la ricchezza, gli obbrobri con Cristo che ne è
ricolmo piuttosto che gli onori, e il desiderare di essere ritenuto stupido e pazzo per
Cristo che per primo fu considerato tale, piuttosto che savio e prudente in questo
mondo” (E 165-167).
2. La Croce come storia trinitaria
Ci accostiamo al mistero della Croce ricordando come nella tradizione occidentale
la Trinità sia stata spesso rappresentata mediante l’immagine del Crocefisso sostenuto
7
dalle mani del Padre, mentre la colomba dello Spirito separa e unisce al tempo stesso
l’Abbandonante e l’Abbandonato (cf. ad esempio la Trinità di Masaccio in Santa Maria
Novella a Firenze e il motivo del “Trono delle Grazie” - “Gnadenstuhl” nella tradizione
germanica). Questa immagine è la traduzione iconografica della profonda idea teologica
che vede nella Croce il luogo della rivelazione della Trinità: la Croce è storia trinitaria di
Dio! Che la Croce sia evento trinitario la fede della Chiesa lo ha intuito molto presto,
come dimostra non solo il grande spazio dato al racconto della passione nell’annuncio
delle origini, ma anche la struttura teologica che soggiace alle narrazioni della passione.
Questa struttura può essere colta attraverso il ritorno costante, certamente non casuale,
del verbo “consegnare” (“paradídomi”): è possibile distinguere due gruppi di consegne.
Il primo gruppo è costituito dal succedersi delle “consegne” umane del Figlio
dell’uomo: il tradimento dell’amore lo consegna agli avversari: “Allora Giuda Iscariota,
uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare loro Gesù” (“ína autón
paradói”: Mc 14,10). Il sinedrio, custode e rappresentante della Legge, consegna Colui
che considera il bestemmiatore al rappresentante di Cesare: “Al mattino i sommi
sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero
in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato” (“parédokan Piláto”: Mc
15,1). Questi, pur convinto dell’innocenza del Prigioniero - “Che male ha fatto?” (Mc
15,14) - cede alla pressione della folla, sobillata dai capi (cf. 15,11), e, “dopo aver fatto
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso” (“parédoken tòn Iesoún”: Mc
15,15). Abbandonato dai suoi, ritenuto un bestemmiatore dai signori della Legge e un
sovversivo dal rappresentante del potere, Gesù va incontro alla morte: se tutto si
fermasse qui, la sua sarebbe una delle tante ingiuste morti della storia, dove un
innocente rantola nel suo fallimento di fronte all’ingiustizia del mondo. Ma la comunità
nascente - illuminata dall’esperienza pasquale - sa che non è così: per questo essa ci
parla di altre tre misteriose consegne.
La prima è quella che il Figlio fa di se stesso: l’ha espressa con evidenza Paolo:
“Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha
consegnato se stesso per me” (“paradóntos eautón upèr emoú”: Gal 2,20; cf. 1,4; 1Tm
2,6; Tt 2,14). “Camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha
consegnato se stesso per noi (‘parédoken eautón upèr emôn’), offrendosi a Dio in
sacrificio di soave odore” (Ef 5,2; cf. 5,25). Si sente in queste espressioni la
corrispondenza con la testimonianza evangelica: “Padre, nelle tue mani affido il mio
spirito!” (Lc 23,46: citazione del Sal 31,6). “E chinato il capo consegnò lo Spirito”
(“parédoken tò pnéuma”: Gv 19,30). Il Figlio si consegna al Padre per amore nostro e al
nostro posto:“Nessuno ha amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.
Voi siete miei amici...” (Gv 15,13). Attraverso questa consegna il Crocefisso prende su
di sé il carico del dolore e del peccato passato, presente e futuro del mondo, entra fino in
fondo nell’esilio da Dio per assumere quest’esilio dei peccatori nell’offerta e nella
riconciliazione pasquale: “Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge,
diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto chi pende dal
legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi
ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede” (Gal 3,13s). Non è il grido di
Gesù morente il segno dell’abisso di dolore e di esilio che il Figlio ha voluto assumere
8
per entrare nel più profondo della sofferenza del mondo e portarlo alla riconciliazione
col Padre? “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34; cf. Mt 27,46).
Alla consegna che il Figlio fa di sé, corrisponde la consegna del Padre: essa è
sottesa alle formule del cosiddetto “passivo divino”: “Il Figlio dell’uomo sta per essere
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno” (Mc 9,31 e par.; cf. 10,33.45 e
par.; Mc 14,41s. = Mt 26,45b-46). A consegnarlo non saranno gli uomini, nelle cui mani
sarà consegnato, né sarà lui da solo a consegnare se stesso, perché il verbo è al passivo.
Chi lo consegnerà sarà Dio, suo Padre: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna”
(Gv 3,16). “Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti
noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?” (Rm 8,32). È in questa consegna
che il Padre fa del proprio Figlio per noi che si rivela la profondità del suo amore per gli
uomini: “In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati” (1Gv
4,10; cf. Rm 5,6-11). Anche il Padre fa storia nell’ora della Croce: egli, sacrificando il
proprio Figlio, giudica la gravità del peccato del mondo, passato, presente e futuro, ma
mostra anche la grandezza del suo amore misericordioso per noi. Alla consegna dell’ira
- “Dio li ha consegnati all’impurità” (Rm 1,18ss.) - succede la consegna dell’amore!
L’offerta della Croce indica nel Padre sofferente la sorgente del dono più grande, nel
tempo e nell’eternità: la Croce rivela che “Dio (il Padre) è amore” (1Gv 4,8-16)!
Alla sofferenza del Figlio, “che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me”
(Gal 2,20), fa dunque riscontro - da essa distinta - una sofferenza del Padre: Dio soffre
sulla Croce come Padre, che offre, come Figlio, che si offre, come Spirito, che è l’amore
promanante dal loro amore sofferente. La Croce è storia dell’amore trinitario di Dio per
il mondo: un amore che non subisce la sofferenza, ma la sceglie. Diversamente dalla
mentalità greco-occidentale, che non sa concepire altro che una sofferenza passiva,
subita e dunque imperfetta, e perciò postula un’astratta impassibilità di Dio, il Dio
cristiano rivela un dolore attivo, liberamente scelto, perfetto della perfezione dell’amore:
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13).
Il Dio di Gesù non è fuori della sofferenza del mondo, spettatore impassibile di essa
dall’alto della sua immutabile perfezione: egli la assume e la vive nel modo più intenso,
come dono e offerta da cui sgorga la vita nuova del mondo. Da quel Venerdì Santo noi
sappiamo che la storia delle sofferenze umane è anche storia del Dio cristiano: Egli è
presente in essa, a soffrire con l’uomo e a contagiargli il valore immenso della
sofferenza offerta per amore. Egli non è “l’occulta controparte” verso la quale si leva il
grido del sofferente e del desolato, ma è nel senso più profondo il Dio con noi, che
soffre con chi soffre e interviene a suo favore con la prossimità della Croce del Figlio. Il
Padre del Crocifisso è il Dio che dà senso alla sofferenza del mondo, perché ha inviato il
Figlio amato ad assumerla fino al punto da farne la propria sofferenza. Questa è la
rivelazione del cuore di Dio: il Padre è colui che soffre perché per amore ci ha creati,
esponendosi volontariamente al rischio della nostra libertà, ed ama anche i peccatori
nell’Unigenito, che si è fatto solidale con loro. Proprio così, Dio Padre è custodia
misteriosa del senso del dolore umano: e questo senso è l’amore.
9
Storia del Figlio, storia del Padre, la Croce è parimenti storia dello Spirito: l’atto
supremo della consegna è l’offerta sacrificale dello Spirito, come ha colto l’evangelista
Giovanni: “Chinato il capo, consegnò lo Spirito” (“parédoken tò pnéuma”: Gv 19,30). È
“con uno Spirito eterno” che il Cristo “offrì se stesso senza macchia a Dio” (Eb 9,14). Il
Crocifisso consegna al Padre nell’ora della Croce lo Spirito che il Padre gli aveva
donato, e che gli sarà dato in pienezza nel giorno della resurrezione: il Venerdì Santo,
giorno della consegna che il Figlio fa di sé al Padre e che il Padre fa del Figlio alla
morte per i peccatori, è il giorno in cui lo Spirito è consegnato dal Figlio al Padre suo,
perché il Crocifisso resti abbandonato, nella lontananza da Dio, in compagnia dei
peccatori. Come l’esilio fu per Israele il tempo in cui gli venne sottratto lo Spirito, così
la consegna che Gesù crocifisso fa dello Spirito al Padre lo introduce nell’esilio dei
senza Dio; e come la patria messianica sarà per i profeti quella in cui lo stesso Spirito
verrà effuso su ogni carne (cf. Gl 3,1ss), così l’effusione pasquale dello Spirito sul
Figlio (cf. Rm 1,4) consentirà ai peccatori ai quali egli si è fatto solidale di entrare con
lui nella comunione della vita eterna di Dio. Nella luce della consegna dello Spirito la
Croce ci appare in tutta la radicalità del suo essere un evento trinitario e salvifico: “Colui
che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi
potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio” (2 Cor 5,21; cf. Rm 8,3). Nell’ora
della Croce, pertanto, lo Spirito stesso fa storia: storia in Dio, perché consegnato dal
Figlio al Padre rende possibile l’alterità del Figlio da Lui nella solidarietà con i
peccatori, pur nell’infinita comunione espressa dell’obbedienza sacrificale del
Crocefisso; storia nostra, perché in tal modo rende il Figlio vicino a noi, consentendo ai
lontani di aprirsi nell’esilio la via col Figlio verso la patria della comunione trinitaria di
Pasqua.
Storia del Figlio, del Padre e dello Spirito, la Croce è dunque storia trinitaria di
Dio: per amore la Trinità fa suo l’esilio del mondo sottoposto al peccato, perché questo
esilio entri a Pasqua nella patria della comunione trinitaria. Proprio così un mistero di
sofferenza si lascia scrutare nell’abisso stesso della divinità: come afferma l’Enciclica
Dominum et vivificantem di Giovanni Paolo II, “il Libro sacro... sembra intravvedere un
dolore, inconcepibile e inesprimibile nelle ‘profondità di Dio’ e, in un certo senso, nel
cuore stesso dell’ineffabile Trinità... Nelle ‘profondità di Dio’ c’è un amore di Padre
che, dinanzi al peccato dell’uomo, secondo il linguaggio biblico, reagisce fino al punto
di dire: ‘Sono pentito di aver fatto l’uomo’... Si ha così un paradossale mistero d’amore:
in Cristo soffre un Dio rifiutato dalla propria creatura... ma, nello stesso tempo, dal
profondo di questa sofferenza lo Spirito trae una nuova misura del dono fatto all’uomo e
alla creazione fin dall’inizio. Nel profondo del mistero della Croce agisce l’amore” (nn.
39 e 41). La sofferenza divina non è, dunque, segno di debolezza o di limite come è la
sofferenza passiva, che si subisce perché non è possibile farne a meno: riferendosi a
questo tipo di sofferenza, segno di imperfezione e di limite, il Catechismo di Pio X
afferma che come Dio Gesù non poteva soffrire. Nelle profondità divine, però, c’è una
sofferenza di tipo diverso, attiva, liberamente accettata per amore. La Croce, in quanto
storia trinitaria di Dio, non proclama la bestemmia di un’atea morte di Dio, che faccia
spazio alla vita dell’uomo prigioniero della sua autosufficienza, ma la buona novella
10
della morte in Dio, perché l’uomo viva della vita del Dio immortale nella partecipazione
alla comunione trinitaria, resa possibile grazie a quella morte. Sulla Croce la “patria”
entra nell’esilio, perché l’esilio entri nella “patria”: in essa è offerta perciò la chiave
della storia!
La Croce rinvia così alla Pasqua: l’ora dello iato rimanda a quella della
riconciliazione, l’impero della morte al trionfo della vita! L’alterità del Figlio dal Padre
nel Venerdì Santo, che si consuma nella dolorosa consegna dello Spirito, il suo
“discendere agli inferi” nella solidarietà con tutti quelli che furono, sono e saranno
prigionieri del peccato e della morte, è orientata, nell’unità del mistero pasquale, alla
riconciliazione del Figlio col Padre, compiutasi al “terzo giorno”, mediante il dono che il
Padre fa dello Spirito al Figlio e in lui e per lui agli uomini lontani, così riconciliati: “In
Cristo Gesù voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al suo
sangue. Egli è la nostra pace... Per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre in un solo
Spirito” (Ef 2,13s.18). Alla lontananza della Croce segue la comunione della
resurrezione: la morte in Dio per il mondo del Venerdì Santo passa a Pasqua nella vita
nuova del mondo in Dio. Proprio in quanto in essa non ha luogo la morte subita a causa
del peccato, ma la morte accettata per amore, la Croce è la morte della morte, che non
lacera, ma riconcilia, non nega l’unità divina, ma sommamente l’afferma in sé e per il
mondo. Se sulla Croce il Figlio consegna lo Spirito al Padre entrando nell’abisso
dell’abbandono da Dio, nella resurrezione il Padre dona lo Spirito al Figlio, assumendo
in lui e con lui il mondo nell’infinita comunione divina: uno è il Dio trinitario che agisce
nella Croce e nella risurrezione, una la storia trinitaria di Dio, uno il disegno di salvezza
che si realizza nei due momenti. Croce e resurrezione sono storia nostra, perché sono
storia trinitaria di Dio!
3. Rivelazione e sequela
La Croce è dunque il luogo in cui Dio parla nel silenzio: quel silenzio della
finitudine umana, che è diventata per amore la sua finitudine! Il mistero nascosto nelle
tenebre della Croce è il mistero del dolore di Dio e del suo amore per gli uomini. L’un
aspetto esige l’altro: il Dio cristiano soffre perché ama ed ama in quanto soffre. Egli è il
Dio “compassionato”, come diceva l’italiano del Trecento, perché è il Dio che patisce
con noi e per noi, che si dona fino al punto di uscire totalmente da sé nell’alienazione
della morte, per accoglierci pienamente in sé nel dono della vita. Nella morte di Croce il
Figlio è entrato nella “fine” dell’uomo, nell’abisso della sua povertà, del suo dolore,
della sua solitudine, della sua oscurità. E soltanto lì, bevendo l’amaro calice, ha fatto
fino in fondo l’esperienza della nostra condizione umana: alla scuola del dolore è
diventato uomo fino alla possibilità estrema. Ma proprio così anche il Padre ha
conosciuto il dolore: nell’ora della Croce, mentre il Figlio si offriva in incondizionata
obbedienza a lui e in infinita solidarietà con i peccatori, anche il Padre ha fatto storia!
Egli ha sofferto per l’Innocente consegnato ingiustamente alla morte: e tuttavia ha scelto
di offrirlo, perché nell’umiltà e nell’ignominia della Croce si rivelasse agli uomini
l’amore trinitario di Dio per loro e la possibilità di divenirne partecipi. E lo Spirito,
11
“consegnato” da Gesù morente al Padre suo, non è stato meno presente nel
nascondimento di quell’ora: Spirito dell’estremo silenzio, egli è stato lo spazio divino
della lacerazione dolorosa e amante, che si è consumata fra il Signore del cielo e della
terra e Colui che si è fatto peccato per noi, in modo che un varco si aprisse nell’abisso e
ai poveri si schiudesse la via del Povero.
Questa morte in Dio non significa in alcun modo la morte di Dio che il “folle” di
Nietzsche va gridando sulle piazze del mondo: non esiste né mai esisterà un tempio dove
si possa cantare nella verità il “Requiem aeternam Deo”! L’amore trinitario che lega
l’Abbandonante all’Abbandonato, e in questi al mondo, vincerà la morte, nonostante
l’apparente trionfo di questa. La sorprendente identità del Crocifisso e del Risorto
mostra apertamente quanto sulla Croce è rivelato “sub contrario” e garantisce che quella
fine è un nuovo inizio: il calice della passione di Dio si è colmato di una bevanda di vita,
che sgorga e zampilla in eterno (cf. Gv 7,37-39). Il frutto dell’albero amaro della Croce
è la gioiosa notizia di Pasqua: il Consolatore del Crocifisso viene effuso su ogni carne
per essere il Consolatore di tutti i crocefissi della storia e per rivelare nell’umiltà e
nell’ignominia della Croce, di tutte le croci della storia, la presenza corroborante e
trasformante del Dio cristiano. In questo senso, la sofferenza divina rivelata sulla Croce
è veramente la buona novella: “Se gli uomini sapessero... - scrive Jacques Maritain - che
Dio ‘soffre’ con noi e molto più di noi di tutto il male che devasta la terra, molte cose
cambierebbero senza dubbio, e molte anime sarebbero liberate”.
La “parola della Croce” (1 Cor 1,18) ci chiama così in maniera sorprendente alla
sequela: è nella povertà, nella debolezza, nel dolore e nella riprovazione del mondo, che
troveremo Dio. Non gli splendori delle perfezioni terrene, ma precisamente il loro
contrario, la piccolezza e l’ignominia, sono il luogo privilegiato della Sua presenza fra
noi, il deserto fiorito dove Egli parla al nostro cuore. La perfezione del Dio cristiano si
manifesta proprio nelle sofferenze, che per amore nostro egli assume: la finitudine del
patire, la lacerazione del morire, la debolezza della povertà, la fatica e l’oscurità del
domani, sono altrettanti luoghi, dove egli mostra il suo amore, perfetto fino alla
consumazione totale. Nella vita di ogni creatura umana può ormai essere riconosciuta la
Croce del Dio trinitario: nel soffrire diventa possibile aprirsi al Dio presente, che si offre
con noi e per noi, e trasformare il dolore in amore, il soffrire in offrire. Lo Spirito del
Crocifisso opera il miracolo di questa rivelazione salvifica: egli è il Consolatore della
passione del mondo, Colui che proclama la verità della storia dei vinti, confondendo la
storia dei vincitori. Egli vive con noi e in noi le agonie della vita, facendo presente nel
nostro patire il patire del Figlio, e perciò aprendovi un’aurora di vita, rivelazione e dono
del mistero di Dio. La “kènosi” dello Spirito nelle tenebre del tempo degli uomini non è
che il frutto della “kènosi” del Verbo nella storia della passione e morte di Gesù di
Nazaret, l’estrema conseguenza del più grande amore, che ha vinto e vincerà la morte.
La Chiesa e i singoli discepoli del Dio trinitario, che soffre per amore nostro,
vengono allora a configurarsi come il popolo della “sequela crucis”, la comunità e il
singolo “sotto la Croce”: preceduti da Cristo nell’abisso della prova, attraverso cui si
apre la via della vita, i cristiani sanno di dover vivere nel segno della Croce le opere e i
giorni del loro cammino. “Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo,
12
ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che
mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). “Ancora peregrinanti in terra,
mentre seguiamo le sue orme nella tribolazione e nella persecuzione, come il corpo al
capo veniamo associati alle sue sofferenze e soffriamo con Lui, per essere con Lui
glorificati (cf. Rm 8,17)” (Lumen Gentium 7). Nulla è più lontano dall’immagine del
discepolo del Crocifisso che una Chiesa tranquilla e sicura, forte dei propri mezzi e delle
proprie influenze: “La cristianità stabilita dove tutti sono cristiani, ma in interiorità
segreta, non somiglia alla Chiesa militante più che il silenzio della morte all’eloquenza
della passione” (Kierkegaard). La Chiesa sotto la Croce è il popolo di coloro che, con
Cristo e nel suo Spirito, si sforzano di uscire da sé e di entrare nella via dolorosa
dell’amore: una comunità di poveri al servizio dei poveri, capace di confutare con la vita
i falsi sapienti e potenti di questa terra.
Una Chiesa sotto la Croce dice anche una comunità feconda nel dolore dei suoi
membri: la sequela del Nazareno, fonte di vita che vince la morte, esige di percorrere
con lui l’oscuro cammino della passione: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà” (Mc
8,34-35 e par.) “Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me” (Mt
10,38 e Lc 14,27). Il discepolo dovrà “completare nella sua carne quello che manca ai
patimenti del Cristo” (Col 1,24): lo farà se riuscirà a portare la più pesante di tutte le
croci, la croce del presente a cui il Padre lo chiama, credendo anche senza vedere,
lottando e sperando, anche senza avvertire la germinazione dei frutti, nella solidarietà
con tutti coloro che soffrono (cf. 1Cor 15,26), nella comunione a Cristo, compagno e
sostegno del patire umano, e nell’oblazione al Padre, che valorizza ogni nostro dolore.
Questa croce del presente è il travaglio della fedeltà ed insieme la persecuzione messa in
atto dai “nemici della Croce di Cristo” (Fil 3,18). La “via crucis” della fedeltà è fatta
dalla lotta interiore e dalle agonie silenziose dei momenti di prova, di solitudine e di
dubbio, ed è sostenuta dalla preghiera perseverante e tenace di una povertà che aspetta la
misericordia del Padre: la stessa “via crucis” della fedeltà di Gesù, con la differenza che
egli fu solo a percorrerla, mentre noi siamo preceduti e accompagnati da lui. La croce
della persecuzione è invece la conseguenza dell’amore per la giustizia e della
relativizzazione di ogni presunto assoluto mondano, da parte dei discepoli del
Crocifisso: la loro speranza nel Regno che viene li fa inquietanti verso le miopie di tutti i
vincitori e i dominatori della storia. “Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi...
E sarete odiati da tutti a causa del mio nome” (Mc 10,16.22; cf. 16ss).
La Chiesa sotto la Croce diventa così, per la sua stessa fame e sete del mondo
nuovo di Dio e per la grazia di cui è strumento, il popolo che aiuta a portare la croce e
che combatte le cause inique delle croci di tutti gli oppressi: essa si confronta con le
prigionie di ogni sorta di Legge e con le schiavitù di ogni sorta di potere, e, come il suo
Signore, si pone in alternativa umile e coraggiosa nei loro confronti. Il Crocefisso non
esita ad identificarsi con tutti i crocefissi della storia: “Avevo fame e mi deste da
mangiare; avevo sete e mi deste da bere; ero forestiero e mi ospitaste; nudo e mi vestiste,
malato e mi visitaste, carcerato e veniste a trovarmi... Ogni volta che avete fatto queste
13
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,35-36.40).
Nei perseguitati è lui che è presente: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?” (At 9,4). Chi
ama il Crocefisso e lo segue, non può non sentirsi chiamato a lenire le croci di tutti
coloro che soffrono e ad abbatterne le cause inique con la parola e con la vita. La croce
della liberazione dal peccato e dalla morte esige la liberazione da tutte le croci frutto di
morte e di peccato: l’”imitatio Christi crucifixi” non potrà mai essere accettazione
passiva del male presente! Essa si consumerà, al contrario, nell’attiva dedizione alla
causa del Regno che viene, che è anche impegno operoso e vigilante per fare del
Calvario della terra un luogo di resurrezione, di giustizia e di vita piena. La compassione
verso il Crocefisso si traduce nella compassione operosa verso le membra del suo corpo
nella storia: per una Chiesa, che si dibatte nel problema del rapporto fra la sua identità e
la sua rilevanza, fra la fedeltà e la creatività audace, questo significa il riconoscimento
della possibilità risolutrice. La Chiesa si ritroverà perdendosi, porrà la sua identità
esattamente nel metterla al servizio degli altri, per ritrovarla all’unico livello degno dei
seguaci del Crocifisso: l’amore.
Al discepolo, schiacciato sotto il peso della croce o spaventato di fronte alle
esigenze della sequela, è rivolta la parola della promessa, dischiusa nella resurrezione,
contraddizione di tutte le croci della storia: parola di consolazione e di impegno, che ha
sostenuto già la vita, il dolore e la morte di tutti quanti ci hanno preceduto nel
combattimento della fede. “Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così,
per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione” (2 Cor 1,5). “Siamo tribolati
da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi; portando sempre e dovunque nel nostro corpo
la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo” (2 Cor
4,8-10). In colui che si sforza di vivere così, la Croce di Cristo non è stata resa vana (cf.
1Cor 1,17): in lui si manifesterà anche la vittoria dell’Umile, che ha vinto il mondo (cf.
Gv 16,33)! Desidero io essere così? sono disposto a leggere la mia vita nella Croce? so
riconoscere la Croce nella mia vita? come vivo l’esperienza della Croce? in che misura
aiuto gli altri a portare la loro Croce? Nella risposta a queste domande ci aiuti il Dio del
dolore d’amore, che vince il peccato e la morte:a Lui ci rivolgiamo fiduciosi con le
parole di un’antica preghiera:
Gesù Crocifisso!
Sempre Ti porto con me,
a tutto Ti preferisco.
Quando cado, Tu mi risollevi.
Quando piango, Tu mi consoli.
Quando soffro, Tu mi guarisci.
Quando Ti chiamo, Tu mi rispondi.
Tu sei la luce che mi illumina,
il sole che mi scalda,
14
l'alimento che mi nutre,
la fonte che mi disseta,
la dolcezza che m'inebria,
il balsamo che mi ristora,
la bellezza che m'incanta.
Gesù Crocifisso!
Sii Tu mia difesa in vita,
mio conforto e fiducia
nella mia agonia.
E riposa sul mio cuore
quando sarà la mia ultima ora.
Amen! Alleluia!
http://www4.diocesi.torino.it/archivio2009/duegiorni/Duegiorni-Forte.pdf

Nessun commento:
Posta un commento