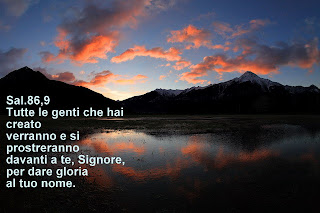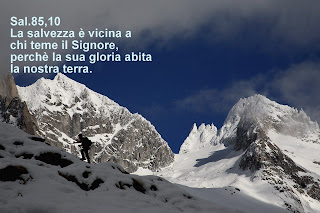1. Segnati dal dolore
Far memoria, dopo più di quattro secoli, dei benefici ricevuti dai nostri padri, liberati dalla peste che aveva colpito la nostra città verso la fine dell’estate del 1576, è più che mai ragionevole. Ha lo spessore del bisogno di liberazione particolarmente sentito, quest’anno, dal nostro popolo. In questi ultimi mesi, infatti, siamo stati ripetutamente e duramente colpiti da eventi che ci hanno costretto a guardare in faccia la realtà del dolore e della sofferenza. La loro presa feroce ha provocato profondi strappi nella spessa coltre di distrazione e di evasione con cui sovente attutiamo l’urto della realtà: dalla vicenda di Eluana Englaro, al violento terremoto negli Abruzzi, alla recente sciagura di Viareggio…
Per non parlare delle conseguenze, a livello planetario, della crisi economica, del tremendo carico di sofferenze e di morte causato da guerre, terrorismo e repressione, dalle contraddizioni legate ai processi migratori, dalle calamità spesso connesse col degrado ecologico… Ma nessuno di questi mali morde la carne come quelli in cui ci imbattiamo direttamente, quando il dolore e la sofferenza ci sorprendono nella malattia e nella morte dei nostri cari e ancor più di noi stessi.
Personalmente sono stato provocato a mettere a tema del Discorso del Redentore il dolore e la sofferenza durante la Visita Pastorale, incontrando nelle loro case alcuni ammalati gravi o gravissimi. La questione si è fatta per me più urgente, direi indilazionabile, a partire dai volti, dagli sguardi e dalle parole, poche ma radicali, che mi sono state rivolte da loro e dai loro cari.
Vorrei, ancora una volta pellegrino con veneziani ed ospiti alla luminosa basilica palladiana, mettere questa esperienza davanti al Redentore. Il Padre infatti, nella sua abissale gratuità, previene la nostra stessa domanda di liberazione dal dolore «nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5,8). Per questo noi possiamo sperare. E la “virtù bambina” della speranza – come genialmente la definiva Péguy – ci consente di chiederGli che la morsa della sofferenza si allenti, almeno suggerendoci come portare il nostro dolore.
2. Dolore, sofferenza ed enigma-uomo
Nella storia dell’umana famiglia l’aggressione del dolore e della sofferenza sembra non spegnersi mai. Incalcolabili sono le sue manifestazioni, né si finisce di immaginarle tanto ci sorprendono, sempre di nuovo, in forme inedite. Come tutte le realtà elementari di cui l’uomo universalmente fa esperienza (la conoscenza, l’amore, ecc.), anche il dolore e la sofferenza sono difficili da spiegare. Dolore e sofferenza non sono fenomeni identici. Il dolore fisico, quando ha la funzione di segnalare una minaccia per la vita, pur essendo l’espressione di qualcosa di negativo, non è in sé e per sé un male. Il male non è il dolore, ma la minaccia per la vita che il dolore segnala. I dolori anginosi, se porteranno alla cura delle coronarie, possono essere considerati un ingegnoso dispositivo della natura che rivela l’esistenza di una minaccia per la vita. Il dolore fisico trapassa in sofferenza quando diventa autonomo, perde questa sua funzione di segnale ed indica una decurtazione della vita. Quando, ad esempio la sordità affligge un violinista o l’artrosi paralizza un chirurgo.
Se guardiamo poi la sofferenza in quanto tale, comprendiamo che talune sue espressioni – come la tristezza per il dolore di un amico o l’ira suscitata da un’ingiustizia subita o il rimorso per un’ingiustizia inferta – non sono sempre qualcosa di male, ma piuttosto una giusta reazione al male, riflesso di autodifesa della dignità dell’uomo. Anche la sofferenza ci appare, in questi casi, più come la conseguenza di un male radicale che la precede che in se stessa un male. «Come il dolore è l’esperienza nel soggetto della minaccia e della decurtazione della vita fisica, così la sofferenza è l’esperienza nel soggetto della minaccia e della decurtazione della vita spirituale» (Spaemann). Queste brevi considerazioni ci consentono un primo orientamento, ma sono ben lontane dal poter spiegare il fenomeno dolore e sofferenza. Che dire, infatti, della sofferenza che noi infliggiamo agli altri? Come non considerare puramente assurda la sofferenza innocente?
I “mali” (malheurs: disgrazie, sciagure, sventure, miseria ecc.), soprattutto quando toccano l’innocente, sono il catalizzatore del “male” multiforme che non a caso il Vangelo chiama Legione. E la morte non ci appare forse come la quintessenza del male, «l’emblema di tutti i disordini» (Merleau-Ponty)? E che dire del male morale (peccato)? Non è esso in qualche modo almeno concausa dei primi due? Non c’è bisogno di scomodare il nesso che il cristianesimo stabilisce tra morte, castigo e redenzione per sentire l’«odore di morte» (2Cor 2,16) che emana dal peccato di cui parla San Paolo («morte, salario del peccato», Rm 8,23).
Vogliamo qui limitarci a riflettere un poco sull’immenso travaglio di dolore e di sofferenza che l’umanità nel suo insieme, ma sempre nella carne dei singoli, deve sopportare.
Se – come diceva Agostino – ogni uomo in quanto tale è “una grande domanda” (magna quaestio), al cuore della domanda-uomo sta l’interrogativo sulla sofferenza e sul dolore.
3. “Gli scaffali della farmacia umana”
Con questa colorita espressione Balthasar descrive i principali tentativi umani di affrontare l’angoscioso interrogativo del dolore e della sofferenza.
Nella sua analisi prende anzitutto in esame due categorie apparentemente opposte, ma in realtà accomunate dallo stesso atteggiamento rinunciatario: il “disfattismo” e la “ribellione”. Vorrei dire una parola su queste posizioni, chiarendo subito che intendo limitarmi a coglierne la radice antropologica senza esprimere giudizi sulle singole persone.
Il “disfattismo” è obiettivamente alla base della tentazione del suicidio, sia esso attuato in prima persona o “assistito”, come si dice a proposito di talune pratiche di eutanasia. Si tratta di una vera e propria «resa davanti ad un eccesso di sofferenza, pensando così di liberarsene» (Balthasar). Il cuore dell’uomo percepisce immediatamente l’estrema fragilità di tale posizione. Anche nel caso, talora richiamato, del suicidio di certi stoici, esso resta, come diceva Wittgenstein, «il peccato per eccellenza». Nel suicidio, quando è compiuto in libertà e con premeditazione, non si offre la vita. La si sottrae a se stessi. Inoltre una simile soluzione è viziata da un esasperato individualismo che non mette in conto la sofferenza arrecata ad altri.
La seconda posizione, la “ribellione”, è autocontraddittoria. Per finire non identifica nessuna persona contro cui ribellarsi. Anche se di volta in volta può chiamare in causa Dio, l’umanità o il male radicale, in realtà si riduce ad una rivolta per la rivolta, estrema quanto velleitaria sfida contro il dolore, nell’illusione di farlo tacere.
Altra è la posizione di chi non si ferma sul soggetto che soffre, ma si impegna per una riduzione progressiva del dolore nell’orizzonte di un più generale progetto di miglioramento del mondo: un nuovo umanesimo in grado di riconciliare l’uomo con la natura (Marx), il passaggio dal nulla all’essere (Bloch), dalla bestialità alla vera umanità (Theilard de Chardin). Un caso particolare è quello di Nietzsche per il quale il dolore esalta la «natura bellicosa dell’uomo» preparando il superuomo. Ma la battaglia contro il male, così concepita, quanta sofferenza del singolo richiede?
Oggi però prende sempre più peso un atteggiamento molto pragmatico che intende aggredire frontalmente il dolore e la sofferenza nel tentativo di eliminarli. Nasce dal potere scientifico e tecnologico che, soprattutto nel campo della medicina, sembra rendere l’uomo padrone della salute e della vita nella convinzione che, in un futuro neppure tanto lontano, il dolore e la sofferenza potranno essere sconfitti.
In questa prospettiva tragedie come quelle dell’Aquila e di Viareggio diventano una pietra di inciampo (scandalo), perché svelano il permanere di una marcata impotenza di fronte alla violenza di certi mali. Rispuntano insicurezza, paura ed angoscia.
Del resto l’attuale ossessione salutista, che persegue solo un indefinito benessere corporale, si scontra con l’esperienza elementare dell’uomo «uno di anima e di corp»” (Gaudium et Spes 14). Nella singolare unità costitutiva della persona si compendiano i vari livelli della vita del cosmo: da quello materiale, vegetale, animale, a quello spirituale che implica conoscenza del mondo esterno, autocoscienza, coscienza morale fino alla libera decisione. La teoria dell’evoluzione nelle formulazioni biologiche più avanzate, così come le neuroscienze anche nelle ardite rivendicazioni del «cervello etico» (Gazzaniga), non possono falsificare l’esistenza di una dimensione spirituale (anima) costitutiva dell’articolata unità della persona.
Diventa allora astratto se non velleitario parlare di salute (e di malattia) se non si identifica un centro dell’io, un luogo di raccordo della dimensione psico-fisica con quella spirituale. Salute e malattia riguardano sempre tutto l’io.
4. La sofferenza radicale di Gesù
Nella vicenda storica dolore e sofferenza, come una tragica fenice, sempre risorgono in forme nuove dalle loro ceneri. A tal punto che l’uomo è tentato di chiamare Dio a discolparsi per l’esistenza del dolore nel mondo. La tradizione cristiana, ma anche il pensiero occidentale (si pensi a Leibniz), registrano continui tentativi di “giustificare” Dio in proposito. Per non attribuire il male a Dio stesso o per non considerarlo un principio originario indipendente da Dio – cioè per non compromettere la bontà di Dio e per non limitare l’assolutezza della libertà divina -, la dottrina tradizionale ha affermato che Dio permette il male a fin di bene. Lo fa per provare l’uomo, per purificarlo o addirittura per far emergere la bellezza del bene ed esprimere l’intera ricchezza del cosmo (Agostino, Tommaso).
La tesi espressa con la categoria della “permissione del male” doveva trovare altre strade perché le ragioni richiamate sono, a gradi diversi, insufficienti o addirittura inaccettabili.
Così in Occidente la riflessione cristiana, in profonda solidarietà d’intenti con il pensiero moderno e contemporaneo, è ritornata sempre di nuovo sul problema. Fino ad introdurre, nel XX secolo, il discutibile tema del “dolore in Dio”. Qualcuno è giunto ad affermare che la sofferenza ha cambiato il volto della teologia: «Il partner della teologia non è più l’incredulo, ma l’uomo che soffre, che sperimenta concretamente la situazione di non salvezza in cui vive e prende coscienza dell’impotenza e finitudine del suo essere» (Kasper).
Dove volgersi?
La Sacra Scrittura illumina aspetti importanti per la comprensione del dolore del mondo (Capitoli 2 e 3 del Libro della Genesi) senza però preoccuparsi di fornire una teoria risolutiva al riguardo. Si limita per lo più a descrivere in vario modo l’esperienza che il credente vive come una prova ultimamente permessa dalla bontà di Dio per la purificazione della propria fede. «Ringraziamo il Signore, nostro Dio, che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare a Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria, quando pascolava le greggi di Làbano suo zio materno». Così il Libro di Giuditta (8, 25-27). Anche il Nuovo Testamento, in modo più essenziale, sostiene che Dio fa passare dal crogiolo del dolore e della sofferenza coloro che gli stanno vicini. Così nella Prima Lettera di Pietro (1, 7), in quella degli Ebrei (12, 6) e nell’Apocalisse (13, 19).
Ma all’uomo che sperimenta il male radicale (Kant), il male ingiustificabile (Nabert), il male innocente (don Gnocchi) la tesi della permissione del male da parte di Dio può bastare?
Gesù Cristo non ha elaborato alcuna teoria per spiegare l’esistenza del dolore e della sofferenza nel mondo. Egli ha imparato «l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto» (Eb 5,8-9) ha attuato un’opera di redenzione in forza della quale ogni sofferenza riceve luce. Per questo «la risposta cristiana al Mistero della sofferenza non è una spiegazione, ma una presenza» (Cicely Saunders).
Nell’opus Dei di Gesù Cristo, il Figlio fattosi uomo per noi, Colui che poteva non morire, morendo ha inchiodato tutto il male assumendolo direttamente su di sé. Non ha sperimentato solamente atroci sofferenze di ordine fisico, ma consegnandosi liberamente alla morte di croce ha fatto un’esperienza irrepetibile di dolore morale: l’abbandono da parte del Padre.
Il grido del Salmo 22 – «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15, 34) – è quello del Figlio, cui il Padre era ben noto. Legato al Padre nel vincolo dello Spirito, Gesù accettò tuttavia di sperimentare nella sua persona il dolore radicale della separazione, apparentemente definitiva, dal Suo Amore. San Paolo scrivendo ai Corinzi usa parole estreme: «Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore» (2Cor 5, 21). Che significa questo? Può voler dire soltanto che Gesù fece l’esperienza del dolore e della sofferenza più radicale: la perdita dell’Amore. Il peccato infatti separa, annulla ogni relazione.
Si intravvede l’abisso del misterioso dialogo tra la domanda angosciata del Figlio abbandonato sulla croce e la risposta del Padre, fatta di silenzio. Lo Spirito Santo però, presente sul Golgota, garantisce il simultaneo «allontanarsi silente come il silente riavvicinarsi» dei Due (Balthasar). Ora «nel silenzio del Padre di fronte alla domanda del Figlio si trova il luogo proprio della sofferenza». Di ogni umana sofferenza.
Gesù ha vissuto questa esperienza liberamente – sponte, dice Sant’Anselmo -. La Sua missione, in obbedienza alla volontà del Padre, non fu solo la scelta della solidarietà di Dio con l’umanità sofferente, ma anche una scelta compiuta al nostro posto. Non solo con noi, ma per noi (sostituzione vicaria). Le sofferenze, la morte e la risurrezione di Gesù hanno la forza di espiare tutti i peccati del mondo. Siamo di fronte al mistero insondabile del dolore umano del Figlio di Dio, al dolore abbracciato dalla libertà umana della Persona divina del Verbo. Niente era più contrario all’innocenza di Gesù quanto l’espiare (purificare, come si evince dalla sua radice etimologica ex-pius) per i peccati che non aveva commesso, ma proprio perché è il “Puro” in assoluto, bevendo il calice della sofferenza come antidoto della morte, vince la morte ed il peccato in nostro favore.
Ci aiuta a comprenderlo qualche dato di esperienza: per l’uomo è impossibile compiere imprese encomiabili di qualsiasi tipo senza una dose elevata di sofferenza; nella vita di ogni uomo non esiste genuina fecondità senza dolore; soprattutto, l’uomo che compie ingiustizia viene restaurato nella sua dignità tramite l’espiazione che lo riconduce nella verità. (Da qui scaturiscono importanti conseguenze per il sistema penitenziario. La pena infligge una sofferenza il cui scopo non può essere la vendetta, ma il medicinale recupero nella verità del condannato).
Il Redentore, morendo sulla croce al nostro posto, svela tutta la fecondità del dolore.
5. La fecondità dell’umana sofferenza
L’opera compiuta dall’amore di Cristo non resta riservata alla sua singolare persona. Tanto meno può essere ridotta a pura sorgente di ammirazione. Essa ha la forza di contagiare ogni umana sofferenza per mutarla in opera di amore e di speranza.
La sofferenza dell’uomo, investita dall’amore del Crocifisso, diventa a sua volta feconda. Per quanti, esplicitamente o implicitamente, aderiscono a Cristo questa prospettiva della vita piena (eterna) è già in atto. Qui, nella storia, non unicamente nell’al di là. Lo confermano molti uomini e donne, non solo i santi già canonizzati dalla Chiesa: la sofferenza è in grado di mutare le sorti della storia personale e sociale (Pastorelli di Fatima), perché partecipa della Redenzione di Gesù.
«Perché mi hai abbandonato?»: una domanda filiale che ha come risposta il silenzio paterno. Non una domanda senza risposta, perché anche il silenzio è una risposta. Non è forse l’esperienza preponderante che ciascuno di noi fa di fronte alla sofferenza altrui? Il restare zitti, il non sapere cosa dire. Orbene, tale silenzio, in maniera apparentemente paradossale (come sempre nella fede cristiana) anziché allontanarci da Dio ci avvicina a Lui: «La sofferenza del mondo ci unisce al cuore di Dio. È un’illusione che “filosofeggia” supporre che la sofferenza avviene “qui sotto”, e “lassù” sta guardando un Dio beato che non vi prende parte. Tutti i pugni chiusi degli uomini rivolti contro il cielo puntano nella direzione falsa. Il sofferente che grida nell’agonia, è in Dio. Egli lo è perché il mondo intero, così come esso è, con tutto il sangue e tutte le sue lacrime è in Cristo e detto più esattamente: nel Cristo crocifisso (e risorto) è stato pensato e creato» (Balthasar).
Il Redentore non ha cercato di cancellare il dolore attraverso una teoria più brillante delle altre, ma ha compiuto un’opera di totale immedesimazione nella sofferenza, illuminandone il significato profondo: la collaborazione alla Sua redenzione del mondo. Per quanto parlare di espiazione delle colpe del mondo possa infastidire la nostra sensibilità post-moderna, non possiamo negare questa realtà. Don Gnocchi, che sarà fra poco proclamato Beato, condividendo lungo tutta la sua vita il dolore e, soprattutto il dolore innocente – quello che più ci tenta di ribellione contro Dio , in un celebre scritto, racconta come i suoi mutilatini, una volta resi partecipi di questa prospettiva, trovassero energia quasi sovrumana di sopportazione del dolore. In tal modo il dolore da condanna diventa merito, da limite espressione di gloria sovrabbondante, da morte risurrezione.
La sofferenza di Cristo è, quindi, inclusiva, cioè consente l’accesso alle altre sofferenze, che possono, in unione con la sua, espiare in modo vicario. San Paolo osa scrivere ai cristiani di Colossi: «Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1, 24).
Qualche settimana fa un padre, parlando del figlio dodicenne appena morto in un incidente stradale, poteva dire: “Non è vero che Dio dà e toglie; Dio dona sempre”. Qui siamo scesi in profondità, ben oltre la tesi della pura permissione del male.
Questa consapevolezza non rinuncia all’indefesso impegno teso a combattere la sofferenza umana, ma – come mostrano le plurisecolari opere di carità cristiana – sprigiona una creatività non utopica.
6. Per una cura integrale
Vorrei ora lasciarmi condurre dalla logica dell’incarnazione propria della fede cristiana a considerare il nostro comportamento di fronte ad alcuni casi di sofferenza estrema. Spesso, davanti a queste situazioni-limite, ci smarriamo e sembriamo incapaci di un atteggiamento costruttivo. Non mi riferisco innanzitutto ad una fragilità personale nel portarle, quanto piuttosto ad una mancanza di chiarezza nel valutarle.
Sto parlando dei malati in stato vegetativo e di quelli terminali. Sollevano questioni scottanti che sono, tra l’altro, proprio in questi giorni, oggetto di dibattito parlamentare. Mi riferisco al Disegno di legge sul fine-vita e a quello sulle cure palliative.
Vista nel quadro delle considerazioni svolte, l’esperienza dell’uomo provato dalla malattia e dalla disabilità, con l’inevitabile carico di dolore e di sofferenza, getta luce anche sull’azione terapeutica della medicina. Questa è autentica solo se l’intervento lenitivo della sofferenza è proposto all’interno di una visione integrale dell’uomo.
Infatti, nella salute e, specialmente, nella malattia («L’uomo nella prosperità non comprende, è come un animale che perisce» ci rammenta con crudezza il Salmo 48), benessere e dolore non sono separabili, come si è visto, da una domanda di significato.
La scienza medica è chiamata a tentare con tutte le sue forze di far regredire il più possibile i confini della malattia e della morte, senza mai dimenticare che anche le situazioni di sofferenza estrema, e perfino il morire, possiedono un significato obiettivo nell’economia della vita umana.
a) Lo “stato vegetativo”
Non pare falsificabile la convinzione, maturata da molti esperti, che quello che comunemente si chiama “stato vegetativo” non sia una malattia, ma la più grave delle disabilità. La vita di chi si trova in questa condizione non dipende dai sempre più sofisticati strumenti della medicina tecnologica né da una particolare terapia medica, ma da quello da cui noi stessi dipendiamo per vivere: l’acqua, il cibo, la mobilizzazione, l’igiene, la relazione e un ambiente disposto a sostenere le nostre fragilità. Lo stato vegetativo, quindi, non ha bisogno di straordinarie apparecchiature di supporto delle funzioni vitali, ma solo di vicariare le esigenze che il malato non è in grado di assolvere da solo: igiene, movimenti, deglutizione (quindi alimentazione e idratazione). Forse questa è la più misteriosa delle situazioni, di grande difficoltà diagnostica, ed interroga molto profondamente sulla dignità della persona umana e sul mistero del suo essere.
Le tecniche della neuroradiologia funzionale mostrano, a detta dei suoi cultori, che la coscienza di colui che si trova in simile stato non è affatto spenta. Inoltre gli esperti che hanno coniato il termine “stato vegetativo” a proposito della sua presunta irreversibilità affermano che questa categoria «non ha valore di certezza, ma è di tipo probabilistico».
La cura della persona in questo stato è, allora, una presa in carico semplice, a basso contenuto tecnologico, anche se ad elevato impegno umano ed assistenziale. Pur consapevole delle forti improbabilità di ripresa, sa accompagnare sempre il paziente, senza mai cadere negli opposti eccessi di un accanimento o di un abbandono.
La letteratura attesta che una simile cura integrale, in taluni casi, consente di ottenere risultati sorprendenti ed assolutamente inattesi come il recupero stabile della coscienza e la capacità di alimentarsi per via orale fino al rientro al domicilio.
b) I malati terminali e le cure palliative
Secondo gli esperti un “caso” assai diverso è quello dei cosiddetti “malati terminali” (ad esempio quelli affetti da SLA). È proprio questo l’ambito in cui si aprono gli interrogativi sui presunti accanimenti terapeutici e sulle pratiche di eutanasia.
Visitando taluni di questi ammalati, mi è sorta una domanda: non siamo piuttosto noi sani a chiedere la “morte degna”, mentre i malati chiedono una vita degna anche con la malattia, una vita degna fino all’ultimo istante, fatta di quello che caratterizza l’uomo: la capacità di amare e di essere amati? Essi hanno il problema del non abbandono, di qualcuno che li accompagni nel percorso di cura in tutte le sue fasi e in tutti i suoi aspetti. Raramente ho intuito la decisiva parte che hanno le relazioni amorose nella cura di un paziente terminale come quando ho visto tre figli – di 8, 10 e 11 anni – accudire un padre quarantottenne malato di SLA in grado di comunicare solo con le palpebre.
Un esempio prezioso e concreto di cosa significhi prendersi cura di questi malati ci viene offerto dalle cure palliative.
La moderna definizione di tali cure, data dalla European Association for Palliative Care, recita: «Le cure palliative sono la cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione. Il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria … Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire un processo naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte, ma quello di preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine». “Inguaribile”, infatti, non è sinonimo di “incurabile”.
Questa definizione appare improntata al più grande realismo. Di essa devono tener particolare conto i curanti, dal momento che non pochi studi hanno mostrato che la domanda di eutanasia o suicidio assistito in pazienti in fase terminale dipende in modo significativo dall’atteggiamento degli operatori sanitari e dei familiari nei confronti della vita, della malattia e soprattutto dell’ammalato.
7. Leggi giuste
Tra i fattori che influenzano in modo sostanziale le scelte della persona – sia perché impongono divieti e riconoscono diritti, sia perché contribuiscono a formare una mentalità – va annoverato il contesto normativo di un Paese. Per questo il legislatore deve riporre la massima cura nel fare leggi oggettivamente giuste.
A proposito della Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), sento la responsabilità di invitare il legislatore a garantire quei principi irrinunciabili più volte richiamati dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Nello stesso tempo il pronunciamento legislativo sulle cure palliative deve essere al più presto attuato e dotato di tutti i mezzi finanziari perché siano capillarmente praticabili nel nostro Paese.
Risorse economiche adeguate vanno investite anche nella normale terapia del dolore.
8. «Nel dolore lieti» (San Paolo)
Dolore e sofferenza, nel loro carattere misterioso consegnato alla libertà di ciascuno di noi, ci hanno portato al cuore dell’amore trinitario che si è coinvolto con questa condizione-limite dell’uomo.
In Cristo Gesù siamo resi capaci della paradossale ma umanissima esperienza vissuta da San Paolo: «nel dolore lieti» (cfr 2Cor 6,10) e di poter così lenire le sofferenze dei nostri fratelli uomini. Per questo ci vuole rispetto della vita, pazienza nell’accompagnamento, ma – soprattutto – educazione al gratuito, all’amore come dono totale di sé.
Questa è la testimonianza che da secoli i cristiani e gli uomini di buona volontà offrono al mondo. Ieri come oggi, migliaia di persone sono vicine ai malati, ai moribondi, agli angosciati che hanno perso tutto, ai troppi provati dalla miseria e dalla fame. L’oceano di carità che anche nelle nostre terre il popolo cristiano, con umiltà ed efficacia, offre a chi è nel dolore è il riverbero di quell’eloquente silenzio che il Redentore non smette di offrirci come credibile risposta al nostro grido di desolazione.
Ma, soprattutto, sono l’offerta di sé e la preghiera semplice (Santo Rosario) di quanti sono vittime del dolore di qualunque genere ad indicarci la grande verità che la vita è fatta per essere donata e non trattenuta: «Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna» (Gv 12, 25).
In quest’ottica l’accettazione dei mali fisici e il pentimento per il male compiuto sono alla nostra portata. Perfino la nostra stessa morte può essere, come supplicava Rilke, personale, se fin dal tempo della prosperità e del benessere la si guarda come autentico dono di sé. Lo sapevano bene i nostri vecchi, usi a recitare la preghiera dell’Apparecchio alla buona morte.
Il mistero del dolore e della sofferenza sta inesorabile davanti a ciascuno di noi, ma il suo valore è già fin d’ora custodito nel nucleo incandescente dell’amore trinitario. Per affrontarli ci è stata donata, quindi, una strada luminosa. A condizione che la libertà di ognuno di noi li assuma quotidianamente nell’orizzonte dell’autentico amore di Dio, degli altri e di se stesso.